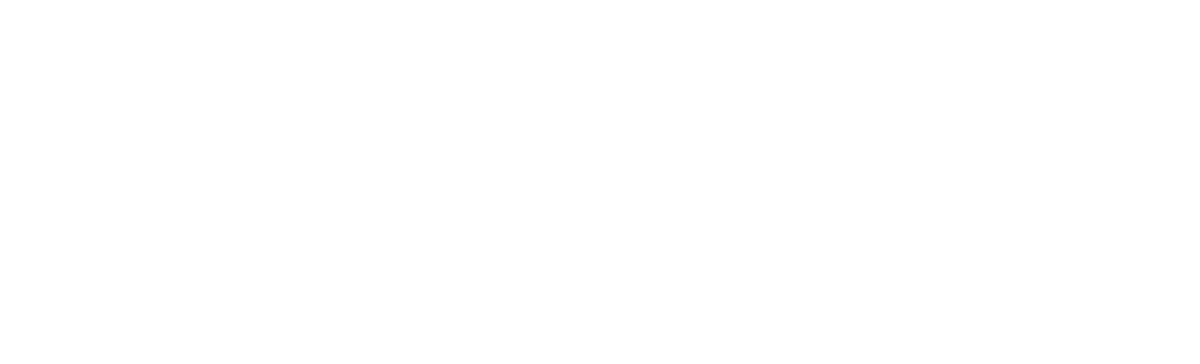Intergenerazionalità, complessità, contribuzione
Per leggere lo sviluppo delle economie e verificarne la sostenibilità nel tempo serve una nuova bussola: la capacità di affrontare con successo la transizione generazionale.
Lo si capisce osservando gli shock globali che si sono susseguiti negli ultimi decenni: non può esserci vera crescita se questa resta schiacciata solo sul breve periodo.
Una società in surplace
L’Italia viene spesso rappresentata come un Paese caotico, ma vitale.
Da sempre poco dotata di organizzazioni di grandi dimensioni, l’Italia è culla di una miriade di piccole imprese e di una fitta rete associativa sostenuta da un volontariato diffuso.
Quello italiano è un contesto ricco e plurale in cui prospera l’iniziativa personale. Non è un caso che il nostro Paese sia riconosciuto nel mondo come la patria della creatività, della vivacità intellettuale, della genialità.
Liberare la generatività per sciogliere 5 nodi che bloccano il Paese
Primo. Investire il futuro
Dal Secondo dopoguerra in poi, il nostro Paese ha raggiunto livelli di prosperità elevati. Eppure, la società italiana continua a guardare al domani con grande incertezza.
Non si tratta solo della difficoltà di interpretare una complessità crescente. Vi sono tracce di una “immaturità” che si traduce nella mancata pro-tensione al futuro.
La visione di breve termine spiegherebbe almeno in parte il basso livello di propensione all’investimento della società italiana. Se il domani è visto con sfiducia, se il futuro è uno spazio ignoto sul quale non si ha alcun potere di azione e non una occasione di miglioramento da costruire insieme, come è possibile investire?
Il Rapporto raccoglie diversi indizi di questo preoccupante sbilanciamento sul presente.
Anzitutto, il ritardo accumulato dall’Italia nel sistema educativo-formativo. Il nostro Paese continua a occupare le ultime posizioni in Europa per quanto riguarda il numero di giovani che non terminano nessun ciclo di studio (drop out), la percentuale di laureati (anche per le fasce giovanili), la spesa delle imprese in formazione continua. I ritardi sono visibili anche per quanto riguarda la formazione digitale – biglietto di entrata nella società di domani – e per la formazione degli adulti.
Altri segnali sono dati dai 1500 miliardi di euro (il 30%della ricchezza mobiliare privata) attualmente fermi nei depositi bancari, che perdono così il loro potenziale di leva di un più ampio sviluppo collettivo, economico e sociale. O dalla vendita di aziende gioiello che, nel momento del ricambio generazionale, vengono cedute permettendo significative capitalizzazioni che non vengono però reinvestite nell’economia reale.
È come se gli italiani fossero focalizzati più a conservare il livello di benessere raggiunto e ad assicurarsi una ciambella protettiva per far fronte agli imprevisti della vita, invece di dedicare pensiero e risorse a preparare il domani.
Diversi fattori possono contribuire a spiegare questa involuzione.
Intanto, un livello di fiducia nelle istituzioni che rimane tra i più bassi a livello europeo.
Quindi, il fatto che in Italia l’assunzione di un rischio di intrapresa (economica, ma anche sociale) non solo non sia premiata, ma perfino tendenzialmente penalizzata. Così che, quando ci si mette in gioco, ci si sente soli.
In terzo luogo, la sottovalutazione della centralità di conoscenza e ricerca. Prevale un’idea di economia basata sullo sfruttamento a breve termine delle opportunità esistenti, piuttosto che la più faticosa costruzione di un percorso di futuro che parta da basi solide e ben fondate.
Infine, la scarsa familiarità con gli strumenti necessari a partecipare alle iniziative imprenditoriali (economica e sociale), a cui si aggiunge lo smantellamento delle forme di finanza locale che, in un modello a economia diffusa e territoriale, avevano permesso in passato una connessione più fluida e diretta tra risparmiatore e investitore.
L’investimento non è un costo.
Investire, piuttosto, è la via per allungare l’orizzonte temporale della vita individuale e collettiva attraverso il riconoscimento di ciò che ha valore e del legame che esiste tra le generazioni.
L’etimologia latina della parola aiuta a riscoprirne il significato più profondo.
Investimento viene da investitura, un termine che indicava l’atto di “mettere in possesso” grazie a una veste ornamentale. L’investimento – si potrebbe dire – è il vestito con cui ci immaginiamo di rivestire ciò che vale. Cioè, l’idea di noi stessi e della società che vogliamo raggiungere. Un movimento, quello dell’investire, che ci permette di andare al di là dell’ordinario, di quanto già c’è, per entrare – già nell’oggi – nel futuro.
Per questo investire è cruciale: nel rilegare passato, presente e futuro, questo movimento mostra come anche un’azione singolare non può non riflettere una convergenza più ampia, condivisa, attorno a ciò che ha valore.
Se pensiamo l’investimento in questa prospettiva, dovremmo concludere che la società italiana fatica a creare le condizioni culturali e istituzionali per rendere possibile, in forma collettiva e non solo individuale, l’avere fiducia in qualche cosa che deve ancora venire.
Eppure, durante il periodo della pandemia, è un’esperienza che abbiamo vissuto. Nel dramma di quei giorni è stato evidente il legame che univa gli uni gli altri e come dalla corresponsabilità di ciascuno dipendeva il raggiungimento di risultati positivi per tutti.
È necessario coltivare questo legame con una comunità più grande del Sé, oltre l’emergenza. Occorre prendersi cura di ciò che una cultura individualistica tende a corrodere.
L’esperienza italiana racconta la possibilità di una convivenza diversa, più resiliente, forte, positiva, e orientata al futuro. Una storia da ritrovare e riattualizzare se vogliamo superare il blocco dell’investimento – che non è solo economico ma sociale, culturale, perfino esistenziale.
Perché è da questa pro-tensione al futuro che un futuro potrà esistere.
Oggi ci troviamo in una fase favorevole, anche grazie all’occasione storica del PNRR. Non si tratta però solo di rispettarne gli obiettivi nei tempi indicati per garantirsi le risorse europee, ma di favorire il ritorno alla centralità dell’investire, personale e collettivo.
L’obiettivo è più grande e ambizioso: costruire un modello di sviluppo più desiderabile, che prenda forma attorno ai due driver di sostenibilità e digitalizzazione.
Potrebbe essere questa per il nostro Paese una occasione straordinaria per attivare e orientare verso un fine comune nuove energie generative.
Secondo. Prima le persone
L’Italia sembra essersi dimenticata che prima, durante e dopo il processo di crescita ci sono le persone. È questo, in sintesi, uno degli aspetti principali fotografati dal Rapporto Italia Generativa.
La demografia ci consegna un’Italia in pieno inverno demografico. Un dato che conferma la disaffezione verso il futuro che da molti anni segna in negativo lo scenario italiano.
La gravità del problema è nota: i tassi di natalità e fertilità italiani sono tra i più bassi al mondo. Contemporaneamente, l’Italia è però anche uno dei Paesi dove si vive più a lungo.
Il risultato di queste due tendenze è l’inversione della piramide demografica: ci ritroviamo con la base più piccola del vertice. Si tratta di una situazione insostenibile e una pericolosa ipoteca sulle possibilità di crescita dei prossimi anni, a partire dagli squilibri del mondo del lavoro e del welfare.
Una seconda conferma ci viene dalla diffusione della povertà infantile.
L’Italia è il Paese dove una percentuale elevata dei suoi pochi bambini vive in condizioni di grave povertà. Difficile dire quale potrà mai essere il futuro di questi ragazzi nell’Italia di domani.
Una terza conferma è data dal basso investimento nell’educazione e nella formazione, di cui si è già detto.
La situazione italiana ha del paradosso: la natalità è in calo e i bambini, i ragazzi e i giovani non sono messi nelle condizioni di far fiorire le loro capacità e competenze. Ma c’è di più. Poiché nel nostro Paese si vide di più e meglio, sulle nuove generazioni ricadranno gli impatti dell’invecchiamento crescente della popolazione.
La società italiana rischia di accartocciarsi su sé stessa.
Per evitare questa implosione sono necessari interventi urgenti che ristabiliscano un maggiore equilibrio negli investimenti a favore delle diverse generazioni. Ad esempio, bilanciando la spesa sociale dedicata alla protezione degli anziani con l’investimento nella formazione dei giovani.
È una priorità assoluta che invece continua a restare marginale nel dibattito pubblico.
Nuovamente, le ragioni di questa “smemoratezza collettiva” sono diverse: la sfiducia nel futuro; la facile ideologizzazione del dibattito attorno alla questione “famiglia”; lo spostamento degli equilibri dell’elettorato causato dalla deriva demografica; l’infragilirsi del legame sociale e intergenerazionale da parte della cultura individualista.
Cosa fare?
La rinuncia alla natalità non ricade solo sulle nuove generazioni, ma mette a rischio la tenuta di un intero Paese. Per questo, se è impensabile invertire la curva demografica nel breve periodo, è però possibile correggere da subito una serie di distorsioni.
Per avere effetti tra 10/20 anni, occorre agire subito.
Oggi lo possiamo fare anche grazie a una maggiore consapevolezza delle cause che alimentano l’inverno demografico e delle leve sulle quali agire.
Anzitutto, le ricerche ci dicono che la radice della questione non è da ricercarsi unicamente nell’atteggiamento dei giovani. Il loro desiderio di genitorialità non risulta diverso da quello dei loro coetanei europei (sebbene anche quest’ultimo sia in calo).
Ancora una volta occorre considerare una pluralità di fattori, ma molti sono gli elementi di contesto che inibiscono la scelta generativa, tra questi l’instabilità delle posizioni lavorative giovanili; il maggior carico di cura in capo alle donne; l’elevato costo della casa (sia in acquisito che in afflitto); il senso di insicurezza economica.
Questo ci dice che cambiare la tendenza demografica richiede un grande sforzo collettivo per arrivare a costruire un ecosistema favorevole alla natalità.
Un ruolo fondamentale lo hanno certamente le amministrazioni locali che possono contribuire direttamente e indirettamente a creare condizioni promettenti.
Un esempio riguarda i servizi all’infanzia, che raramente sono una priorità nell’agire delle Pubbliche Amministrazioni. La carenza di asili nido e di servizi per la prima infanzia costituisce un handicap decisivo per molte famiglie e impediscono a molte donne di partecipare al mercato del lavoro.
La filiera scolastica e formativa – pubblica e privata – ha anch’essa una grande corresponsabilità. Molto ancora resta da fare per migliorare l’alleanza tra la famiglia e le agenzie educative che le sono da complemento. A livello territoriale sono fondamentali le sinergie e le iniziative di rete, come lascia intravvedere l’esperienza delle scuole aperte e partecipate.
Non meno importante è il coinvolgimento del mondo delle imprese, sia sul fronte sostegno alla natalità che della conciliazione famiglia e lavoro.
Diversamente da altri Paesi europei, in Italia l’uso del part-time e l’adozione di policy di conciliazione sono ancora poco diffuse. Questo è un handicap non solo per le donne (sia quelle che desiderano avere figli, sia per quelle che hanno già figli), ma per tutto un ecosistema familiare e sociale.
La maternità è ancora, purtroppo, penalizzante e penalizzata nel nostro Paese.
Per questo è necessario un cambiamento sistemico: legislativo, normativo, culturale e sociale.
A ciò si aggiunge il tradizionale ruolo di cura della donna che più facilmente si trova a gestire carichi di accudimento di genitori anziani o altri parenti fragili. Congedi disegnati in senso più paritario tra i generi potrebbero essere di aiuto.
A questo riguardo si deve sottolineare con forza che il futuro dell’Italia passa in larga misura dalla capacità di affrontare la questione femminile. Il Paese vive bloccato in un paradosso: mentre le giovani donne sono più istruite, il tasso di attività, il livello degli stipendi e le possibilità di carriera sono inferiori. È evidente l’intreccio con la questione demografica: ecco perché è urgente ripensare l’intera agenda socioeconomica “al femminile”.
Le profonde trasformazioni della struttura demografica in Italia riflettono, infine, gli importanti mutamenti avvenuti nei percorsi di vita delle persone, che oggi appaiono molto diversi rispetto a quelli di alcune generazioni fa.
Come affrontare questi cambiamenti strutturali?
L’allungamento della vita, l’aumento della componente anziana e il degiovanimento della popolazione richiedono creatività e flessibilità per identificare nuove opportunità per le diverse fasi e i diversi passaggi.
Certamente andranno ripensati i sistemi formativi, nella prospettiva del long life learning.
Ma a cambiare dovranno essere anche i percorsi professionali che potranno prevedere periodi di alternanza tra lavoro, apprendimento e attività di cura, così come forme progressive di pensionamento e di partecipazione sia alla vita produttiva che sociale e civica.
Non ultimo, il tema migrazioni.
Il Rapporto evidenzia come l’apporto delle risorse migratorie abbia contribuito a mitigare, nel nostro Paese, l’effetto denatalità. È però difficile pensare che la soluzione immigrazione possa risolvere totalmente la questione. Occorre infatti considerare l’influsso della cultura italiana sulle famiglie immigrate che, come le ricerche confermano, non tardano ad adottare gli stessi stili e le medesime strategie di vita delle famiglie italiane, con una riduzione importante del numero di figli per famiglia.
L’immigrazione costituisce e continuerà a costituire una risorsa importante per l’Italia anche a livello lavorativo, a patto, però, di ridefinire i percorsi professionali delle persone in senso maggiormente inclusivo e valorizzante le loro capacità e competenze.
Occorre avere il coraggio di illuminare l’altra faccia della luna: esiste e va smantellato il sottobosco dell’economia sommersa e precaria fondata sullo sfruttamento estrattivo del capitale umano che vede coinvolte soprattutto le forze dei migranti. Togliere dall’invisibilità è il primo passo per dare dignità alle persone e portare alla luce nuove potenzialità economiche di più lungo periodo.
Terzo. Contro la disuguaglianza demotivante (nonostante la spesa sociale)
Il welfare italiano rappresenta una grande conquista culturale e un’infrastruttura sociale fondamentale. Un sistema che garantisce la soddisfazione dei bisogni di base dei cittadini e allo stesso tempo ne promuove l’integrazione.
Non mancano le pressioni per una sua revisione, ma è impensabile un’Italia senza welfare.
È pur vero, però, che la spesa sociale italiana ha raggiunto oggi cifre talmente rilevanti (e tendenzialmente ancora in crescita) da porre il tema della sua sostenibilità.
In tema di welfare, il Rapporto riprende alcuni nodi già conosciuti, ma ancora una volta poco affrontati in chiave sistemica e intergenerazionale.
In primo luogo, la povertà.
Negli ultimi mesi, in Italia il numero delle persone in povertà ha toccato i 6 milioni. Una cifra impressionante, che rappresenta quasi il 10% della popolazione e percentualmente coinvolge più i minori di 18 anni che gli over 65enni. Si tratta di fenomeno dalle proporzioni inaccettabili per un Paese che è pur sempre una delle maggiori economie occidentali.
Gli andamenti della povertà sono allarmanti, soprattutto se si considera l’impegno non risibile dello Stato, a cui va aggiunto quello capillare e spesso invisibile del Terzo settore.
In una società avanzata, la povertà (assoluta e relativa) è certamente riconducibile alla dimensione economica. Ma la povertà è sempre multidimensionale. Essa affonda le sue radici in e, insieme, alimenta altre fragilità personali e familiari – psichica, formativa, professionale, relazionale, culturale – che finiscono però per sfibrare l’intero tessuto sociale.
In secondo luogo, la persistente disuguaglianza che anche in Italia continua a tramandarsi di generazione in generazione. Ancora oggi, l’appartenenza familiare gioca un ruolo rilevante nel disegnare i destini dei giovani. Questo riguarda sia i titoli di studio – dove la probabilità di laurearsi è correlata al percorso scolastico dei genitori – sia il reddito atteso – dove a penalizzare è la situazione economica della famiglia di origine.
Ormai da molti anni la mobilità sociale ascendente si è fermata nel nostro Paese. Così il sistema di opportunità finisce per essere tramandato dai genitori ai figli.
Nonostante la sua universalità e sostanziale mancanza di vincoli nei suoi passaggi, la scuola italiana e, più in generale, il sistema di welfare non riescono ad intaccare la struttura delle disuguaglianze che, nel nostro Paese, rimangono rilevanti e intergenerazionalmente stabili.
Di fronte a questo quadro, l’effetto di demotivazione è evidente.
In Italia, un giovane difficilmente riesce a riconoscere il suo Paese come una terra di opportunità. A differenza di quanto è accaduto ai suoi nonni nei primi decenni del Dopoguerra, l’Italia appare oggi un posto dove è già tanto sperare di conservare quello che si ha.
Il senso di frustrazione è comprensibile, ma questo finisce per alimentare nuova sfiducia nel sistema Italia e nel futuro. Mentre potenzia la spinta antigenerativa, sia a livello sociale che biologico.
Gli strumenti messi in campo dal welfare non mancano, ma spesso solo tamponano i problemi, mentre sale la perplessità sull’efficacia di quegli stessi interventi.
Come spesso accade in Italia, la discussione diventa prigioniera di facili strumentalizzazioni che non contribuiscono però al miglioramento delle policies.
In realtà, misure universalistiche di protezione sociale sono presenti in tutti gli altri Paesi europei e non vi è ragione perché anche l’Italia non possa allinearsi, ma anche a partire dalla prospettiva offerta dal presente Rapporto è utile evidenziare due aspetti sui quali appare necessario intervenire.
Il primo è un corretto inquadramento di ogni strumento rispetto a tutti gli altri interventi che lo Stato italiano elargisce in tema di protezione sociale, a cui si aggiungono i fondamentali supporti da parte del Terzo settore. Si tratta di fare chiarezza sulla qualità e quantità delle risorse che arrivano sui territori e alle singole persone, nel quadro di una visione integrata, coordinata e il più possibile equa dell’azione di welfare.
Il secondo riguarda la capacità di attivazione, promozione e capacitazione della persona assistita: ogni iniziativa deve essere collocata in un sistema di azioni che, in modo chiaro e coerente, si prefiggano di reinserire il prima possibile il beneficiario nella vita attiva, non certo a creare nuova dipendenza.
È facile comprendere perché l’azione di welfare sia spesso vista più come un costo che come un investimento sulle persone. È fondamentale abbandonare la logica dell’assistenza per abbracciare quella della capacitazione generativa.
In questo scenario, rimane pertinente l’immagine della società signorile di massa proposta qualche anno fa da Luca Ricolfi. È un rischio da cui guardarsi, perché condanna intere componenti della società italiana ad una spirale regressiva, e dunque antigenerativa. Una società – quella descritta – in cui la scarsa propensione all’investimento convive con la creazione di nicchie di protezione associate a forme economiche marginali o a trasferimenti pubblici non sempre efficaci e puntuali che non di rado sopravvivono sfruttando e ricreando disuguaglianza (lavoro marginale, precario se non addirittura in nero, immigrazione semi clandestina).
La disponibilità di manodopera a bassissimo costo – una sorta di sottoproletariato – contribuisce a reggere un’impalcatura di rapporti sociali centrati sul breve termine e sullo sfruttamento, ma proprio per questo in grado di garantire ad alcuni ceti sociali un agio improduttivo.
Quarto. L’ecosistema della singolarità (per ricucire la Penisola)
Il sistema socioeconomico italiano continua ad essere connotato da alcune peculiarità che, però, restano poco riconosciute e valorizzate.
L’Italia possiede un’economia caratterizzata dalla presenza di pochissimi grandi gruppi e da un universo di piccole e piccolissime imprese che fanno riferimento ad un numero relativamente ampio di medie imprese industriali.
È questo straordinario reticolo di scambi, collaborazioni e interdipendenze a costituire la parte più viva e dinamica del nostro sistema economico su cui si regge l’eccellenza di uno dei marchi più famosi al mondo: il Made in Italy.
Questo modello di pensare il lavoro, la produzione, l’innovazione si richiama ad una conformazione urbana caratterizzata da una rete di città medio e medio-piccole. Una organizzazione, quella italiana, molto diversa dalle grandi conurbazioni presenti in altri Paesi.
Ancora oggi il valore di questo modello non riesce ad essere pienamente compreso, nei suoi pregi e nei suoi difetti, e valorizzato per le sue potenzialità. Prevale una contrapposizione di scuola che, rimanendo prigioniera di categorie e riferimenti decontestualizzati, finisce per restare sterile.
Il dibattito sembra ruotare attorno a due polarizzazioni: verticale/orizzontale e concentrazione/dispersione.
Da una parte, ci sono coloro che considerano la struttura economica italiana un’anomalia da correggere. Così si sollecita una evoluzione verso una maggiore concentrazione e verticalizzazione.
Dall’altra parte, si rivendica la diversità italiana senza però interrogarsi sulle condizioni della sua stessa riproduzione. Si tratta di una posizione non meno pericolosa, perché rischia di trasformarsi in una implicita ammissione di marginalità del nostro Paese, tra l’altro perfettamente funzionale ad alcuni aspetti negativi della società italiana come l’evasione fiscale, il lavoro nero, la cultura dell’opportunismo.
Nella prospettiva della generatività sociale, questo dibattito va superato.
Intanto va ricordato che l’Italia è l’ITALIA solo se e quando è in grado di riprodurre e riattualizzare continuamente quella qualità e quella varietà che il mondo ci invidia. Ma ricordando che qualità e varietà non sono figlie della genetica, bensì di un contesto sociale costituito e continuamente informato dalle due dimensioni sopra richiamate.
Questo apre la riflessione attorno alle precondizioni socioculturali che consentirono a queste dimensioni di rigenerarsi continuamente e ad ogni livello. Riflessione che nel nostro Paese continua a mancare.
D’altro canto, è evidente che il nostro modello corre sempre il rischio di pervertirsi in una logica di breve termine, di estrazione di valore, di sfruttamento del lavoro e dell’ambiente, di opportunismo privato nei confronti del bene comune.
Questo rilancia la necessità di un nuovo impegno nell’educazione, nella promozione della cultura, nella partecipazione alla vita civica e politica, nella cura dei legami e del rinnovamento istituzionale.
La prospettiva della generatività sociale consente di sfuggire a queste opposizioni per aprire a nuovi immaginari che possano mettere a valore l’unicità italiana.
Usando nuovamente una metafora, si potrebbe raccontare l’Italia non come una foresta popolata da alberi ad alto fusto, ma una macchia vitale, dal ricco sottobosco.
Un luogo di relazione, dove le piante possono fiorire solo grazie ad un ecosistema adatto e dotato di tutto ciò che permette la continua rigenerazione di ogni sua parte e dell’habitat nel suo insieme.
Dove far fiorire la pluralità significa garantire l’ossigeno alle singolarità.
Usciamo dalla metafora: è evidente che un’economia basata su piccole e medie imprese, in un tessuto di città piccole e medie, sia molto più sensibile – rispetto ad altri modelli maggiormente verticali e concentrati – alla qualità del suo ecosistema.
Altrettanto chiaro è il fatto che, da soli, non c’è alcun sviluppo. Individualmente non ci può essere nessuna crescita. Specie in un momento storico in cui le condizioni della vita economica e sociale virano verso il tema della sostenibilità.
Questo implica la necessità – ma ancor prima il desiderio – di prendersi cura dell’ecosistema (sociale e ambientale) per riattivare la generatività spontanea del sistema Italia.
Ma come? E in quale direzione lavorare?
Il Rapporto illumina alcune condizioni che individuano altrettante leve.
Anzitutto, la centralità della conoscenza diffusa. Serve un investimento convinto per migliorare la qualità del sistema formativo, dall’infanzia all’università, dal long life learning alla ricerca. Fondamentale sarà la collaborazione tra imprese, scuola, università.
Importante è anche raggiungere una accessibilità e una migliore efficienza e semplificazione della Pubblica Amministrazione a vantaggio di un dialogo più evoluto tra cittadinanza e istituzioni.
In terzo luogo, è indispensabile ricostruire la fiducia tra il mondo delle imprese e lo Stato, presupposto per una vera ed efficace semplificazione della burocrazia. Le riforme della pubblica amministrazione e della giustizia sono due urgenze che non possono più aspettare.
Non meno rilevanti sono la revisione e la riduzione del carico fiscale, premiante per chi investe e che si assume il rischio dell’intrapresa.
Infine, serve un investimento sulla dotazione infrastrutturale, nodo da sciogliere per la modernizzazione del Paese, necessaria ad incentivare connessioni e mobilità più semplici e accessibili. Il PNRR è l’occasione irripetibile per interrompere la spirale negativa degli ultimi anni: dalla sua attuazione – che deve coniugare tempestività e efficacia – dipende gran parte del futuro dell’Italia.
Guardando all’intera Penisola, va detto che molto già si muove e lavora, ma restano divisioni profonde, con ampie disomogeneità territoriali (sul piano dello spazio) e significative discontinuità (sul piano del tempo).
Alcune condizioni favorevoli alla rigenerazione dell’originale tessuto socioeconomico italiano sono discretamente presenti al Centro-Nord, anche se con diverse smagliature. Al Sud e nelle aree interne del Paese, la situazione è però ben più grave.
Come segnalano i dati del Rapporto, continuano ad esistere ampie zone a rischio di depressione; altre di vera e propria desertificazione, economica prima, e sociale poi.
Si tratta di un quadro per alcuni aspetti in peggioramento (si pensi agli esiti negativi dei risultati scolastici) rispetto ad un gap storico che non si è mai riusciti a ricomporre. Certamente, una delle eredità più amare del Paese.
Rispetto al fattore tempo, segnali preoccupanti sono il tasso di nascita e di sopravvivenza delle nuove imprese, entrambe più basse delle medie europee. Questo sembra suggerire che le condizioni ecosistemiche più adatte all’intrapresa sono diventate più rarefatte.
Proprio per questo è venuto il momento di invertire coraggiosamente la tendenza con un’azione più incisiva, integrata e lungimirante.
Quinto. La nuova cornice del bene comune della sostenibilità
Il Rapporto illumina alcune aree di interessante dinamismo del nostro Paese.
Sui temi dell’ambiente, le statistiche danno conto di un’Italia attenta, almeno per quanto riguarda alcuni comportamenti virtuosi.
È il caso del riciclo dei rifiuti, ambito in cui viene superata la media europea.
In tema inquinamento dell’aria, le performance italiane migliorano.
Anche nel settore delle energie rinnovabili, se ancora molto resta da fare, sono stati compiuti importanti passi in avanti che si spera non vengano frenati dalla guerra, ma accelerati, con l’obiettivo di raggiungere al più presto l’indipendenza energetica.
Particolarmente significativo è soprattutto l’evoluzione dell’economia circolare che vede il nostro Paese tra i principali protagonisti della transizione ambientale, con nuove filiere produttive, del riciclo, del riuso, anche grazie ad un modello produttivo che si lega strettamente al territorio.
I positivi posizionamenti a livello ecologico e ambientale danno conto di un importante potenziale dell’Italia, anche se restano alcune zone d’ombra.
Anzitutto, il decennale sfruttamento e la vasta incuria del territorio che continua a causare vittime e danni ingenti anche (ma non solo) a seguito degli effetti del cambiamento climatico. Il problema del dissesto idrogeologico è noto. È come se il Paese non riuscisse a “vedere” il patrimonio ambientale di cui dispone e trasformarlo in una risorsa per il proprio futuro.
Il crescente utilizzo del suolo e il suo inquinamento pregiudicano gli stessi servizi ecosistemici di cui beneficia la popolazione. Si incomincia a toccare con mano quanto delicata sia la relazione tra natura, economia, salute e benessere.
In terzo luogo, le aree interne. Si tratta di territori a rischio di degrado a causa di una evoluzione socioeconomica che negli ultimi decenni ha rafforzato, invece di mitigarli, i processi di spopolamento delle zone marginali a favore delle città. Questo causa importanti disequilibri, in un Paese che dovrebbe promuovere la sua incredibile varietà di habitat e culture in un mondo sempre più omologato.
Una quarta questione riguarda l’acqua, bene storicamente dato per scontato nel nostro Paese. Secondo gli ultimi studi, in Italia il rischio siccità è aumentato di venti volte.
È un intreccio di fattori quello che espone ampiamente l’Italia a scenari di rischio crescenti a causa dell’incuria in cui resta abbandonato buona parte del territorio nazionale.
Più in generale: il nostro Paese fatica ad impostare una politica del territorio all’altezza della congiuntura storica. Non è consapevole e forse neppure preparato a proteggere la straordinaria dotazione di biodiversità che lo caratterizza e lo rende famoso in tutto il mondo.
Eppure, la sostenibilità, in senso lato, è la leva cruciale per ripensare allo sviluppo del Paese.
Non si tratta di un tema da addetti ai lavori, anche se sarà centrale il coinvolgimento del mondo della produzione e dell’innovazione tecnologica.
Il vero nodo che la sostenibilità porta alla luce riguarda il mancato riconoscimento della relazione come fondamento di ogni pensiero sull’economia e sulla società, sulla crescita e dunque sul futuro.
Proprio perché tutto è in relazione con tutto, noi abbiamo i problemi che abbiamo.
Come suggerisce l’Agenda ONU 2030, se correttamente interpretata, la sostenibilità è una grande opportunità per cambiare il paradigma dello sviluppo socioeconomico che oggi si trova davanti ad un tornante storico: per affrontare i fenomeni complessi che incidono sul cambiamento climatico e sugli squilibri socioeconomici connessi, non basta stimolare l’iniziativa individuale, che pure è importante.
Sarà, invece, la capacità di avviare pratiche collaborative in vista del raggiungimento di obiettivi comuni a fare la differenza. Secondo un modello universalistico che si può definire sostenibile-contributivo.
Su questo aspetto, il Rapporto ci segnala delle criticità che potrebbero diventare occasioni per avviare percorsi autenticamente nuovi.
Storicamente l’Italia si caratterizza per la ricchezza della sua società civile, pur nel quadro di un rapporto non sempre facile con le istituzioni pubbliche. Oggi quel livello di partecipazione attraverso l’associazionismo e il volontariato è in calo, muovendosi verso valori perfino più bassi di quelli che si osserva in altri Paesi. A ciò si aggiunge una diffusa sfiducia nella mano pubblica, che pure ha raggiunto una dimensione molto consistente rispetto all’economia e alla società italiana.
Tutto ciò tende a legittimare comportanti opportunistici che generano però profonde distorsioni. Il fatto che la metà degli italiani versi poco più del 3% del gettito IRPEF, (per un valore di 5,2 miliardi) implica un trasferimento di ricchezza assai consistente (si tenga conto che per garantire solo l’assistenza sanitaria al 50% dei cittadini pressoché incapienti lo stato spende 52,7 miliardi).
Il che spiega anche come mai uno più grandi debiti pubblici dei paesi avanzati conviva con una ricchezza privata tra le più elevate al mondo.
Al di là della retorica, l’Italia rimane segnata dalla difficoltà di trovare i modi – ma forse, ancora più profondamente, le ragioni – per coltivare quel bene comune senza il quale non è possibile generare nessuna crescita che corrisponda a criteri di sostenibilità.
Una difficoltà che, bene inteso, nasce anche dalla disillusione verso uno Stato-idra che sembra solo inghiottire qualunque risorsa in un sistema per molti aspetti poco efficiente, e talvolta corrotto e clientelare.
Siamo alla fine di un ciclo – quello cominciato negli anni Ottanta – che ha visto la partecipazione svilupparsi attorno all’idea di volontariato come membrana tra lo Stato e il Mercato, da cui ha preso forma il Terzo settore. Che oggi qualcuno chiama “Terzo pilastro.
La rigenerazione della partecipazione, la ricostruzione di un’idea di bene comune, la creazione di una nuova economia libidica post-consumerista oggi sono possibili solo attorno alla sostenibilità, dentro una logica generativa.
Un’indicazione importante viene dai cambiamenti culturali che si intravedono nelle culture delle popolazioni più giovani. Alla ricerca di un migliore equilibrio tra le diverse dimensioni esistenziali, i giovani sono attratti da stili di vita in grado di garantire stabilità organizzativa ed emotiva.
Con il desiderio di “staccarsi” da lavori troppo invasivi, da realtà relazionali considerate “tossiche”, da contesti abitativi che impongono modelli di vita eccessivamente schiacciati sulla dimensione strumentale, le nuove generazioni sembrano aspirare ad una vita maggiormente sostenibile, nel quadro di un cambiamento più generale dei valori di riferimento.
È questa la leva di una nuova dinamica generativa in grado di attivare nuove energie psichiche ed economiche, sociali ed istituzionali.
Un orizzonte verso cui un Paese in surplace può decidere di lanciarsi con tutte la creatività, l’intelligenza e la pluralità di cui è capace.
Non è affatto detto, però, che il mondo adulto sia in grado – o disposto – a dare il giusto peso a queste aspirazioni. Tanto più se le giovani generazioni sono troppo poco numerose e troppo poco combattive per forzare un cambiamento che fatica a venire.
Il rischio è che le nuove istanze vengano riassorbite nella staticità caotica della società italiana. Che tutto si risolva in un pallido adattamento e alla difesa di quella comfort-zone garantita dalle condizioni di contesto (la famiglia, in primis, oltre che le diverse forme di protezione statale dall’altro).
Così l’immagine del surplace attribuita al Paese ritorna come fantasma, diventando per molti una personale strategia di vita. O, meglio, di sopravvivenza.
Ma c’è un’altra possibilità. Al grande bivio storico nel quale ci troviamo potrebbe aprirsi per il sistema Italia l’opportunità di ritrovare la sua radice di civiltà.
Per essere civile una società ha il compito di riuscire a pensare sé stessa in un modo critico e coraggioso; imparando a riscoprire e a praticare dei limiti; a stare in una posizione di equilibrio da contrapporre all’inerzia statica di uno sviluppo strutturalmente debole e difettoso, iniquo e inquinante. Pur sapendo che questa ricerca creativa è un esercizio scomodo, esposto a rischi, stretto com’è tra indecisione e slancio vitale.
Questo scarto tra certezze abbandonate e nuovi significati è fragile e transitorio, e idee chiarissime si può solo fingere di averle, perché è difficile capire cosa ci aspetta.
Eppure, questo doppio, quasi impercettibile movimento dell’andare avanti e indietro col pedale del surplace è il protagonista dell’azione proiettata in avanti e ne inquadra la sua paradossalità: al posto della stasi c’è la scommessa di una tensione generativa che nonostante le avversità resta in sella, non si arresta e coglie, responsabilmente, le opportunità di crescita a venire. È capacità di giocarsela tutta (e tutti insieme) per superare la condizione instabile.
Se la tensione generativa viene arrestata si esce dal gioco del cambiamento. Ma la via che resta, a quel punto, è solo quella della stagnazione e della degenerazione.
Viceversa, la strada della trasformazione è quella che oppone l’equilibro alla rottura, la libertà di intraprendere alla chiusura corporativa.
L’Italia generativa che c’è è forse la prova che la storia non torna indietro e che tutto non può (e non deve) tornare come prima.
È un’Italia capace di guardare l’Europa e di guardarsi dentro, che chiama in causa alla radice l’attuale modello di sviluppo di cui prova a riscrivere le regole del gioco.
Ciò che allora si discute nel Rapporto – e su cui si mettono al lavoro i dati e le policy a corredo – introduce argomenti inabituali con uno sguardo altrettanto insolito.
È il tentativo di disegnare, anche graficamente, un potenziale trasformativo e contributivo.
È lo sforzo di trovare senso e fiducia nell’esemplarità delle pratiche.
È – auspicabilmente – una proposta attorno alla quale provare a risollevare il livello del dibattito pubblico del nostro Paese intorno alle scelte – ovvero alle non-scelte – dei decisori.