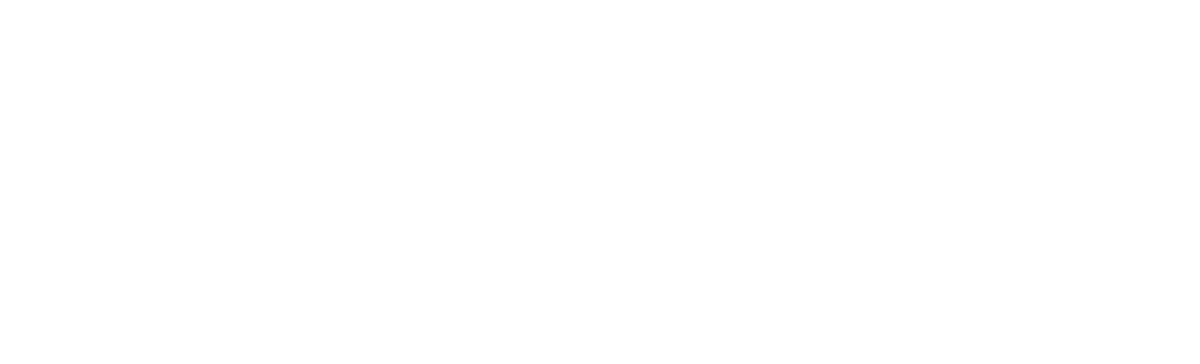CONSIDERAZIONI FINALI
NUOVA ENERGIA IMPRENDITORIALE
1 - NUOVA ENERGIA IMPRENDITORIALE
Le energie imprenditoriali – sempre versatili e in grado di modificare continuamente i propri parametri di orientamento – rappresentano la tensione verso il futuro delle comunità economiche. Come evidenziato dalla letteratura internazionale, si tratta di una spinta profonda, non riducibile alla sola dimensione razionale, ma strettamente legata alle fasi storiche attraversate dalle comunità stesse. È quindi essenziale interpretare i fenomeni dell’imprenditorialità alla luce del contesto attuale che l’Italia e l’Europa stanno vivendo.
Se così affrontata, la questione chiama immediatamente in causa almeno due fattori che incalzano lo scenario attuale: anzitutto il preoccupante declino demografico che disegna per il nostro Paese una traiettoria di difficile inversione nel breve periodo, e la velocità dei processi globali geopolitici e geoeconomici, una variabile indipendente altamente instabile.
L’immaginario tradizionale dell’imprenditore italiano è quello di un uomo adulto, intraprendente e innovatore; capace di combinare capitale e lavoro; attivo nel settore industriale e dei servizi. Un modello emblematico dell’Italia della seconda metà del Novecento, caratterizzata da popolazione in crescita e da un’economia in rapida espansione.
Un Paese che non c’è più. L’Italia non si trova più nella sua fase propulsiva in cui guardava al domani con ottimismo e fiducia. Oggi il processo imprenditivo va analizzato e valutato in un’epoca radicalmente diversa, segnata da una prolungata fase di crescita economica stagnante, da significative disuguaglianze e da una diffusa incertezza per il futuro.
Sebbene ancora oggi persista l’idea tradizionale dell’imprenditore, non sorprende che, nei fatti, la leva dell’imprenditorialità e lo stesso panorama imprenditoriale si stiano almeno in parte diversificando, con l’emergere di una pluralità di forme e protagonisti.
Un primo elemento da considerare è l’invecchiamento della popolazione imprenditoriale. Pur confermando l’Italia un Paese con una spinta all’intrapresa ancora significativa, i dati segnalano il fenomeno, in particolare nel Centro Italia, area a cui – tra l’altro – non sembra corrispondere una particolare vivacità per quanto riguarda l’intrapresa giovanile. Così come il mercato del lavoro sta guardando con preoccupazione all’uscita della generazione “boomer” a motivo del conseguente skill shortage, non di meno appare urgente affrontare la questione anche sul lato imprenditoriale.
È questo un punto di riflessione importante: non è infatti per nulla scontato che il ricco patrimonio imprenditoriale ereditato dalle generazioni passate transiti senza perdite alle più giovani. Diversi fattori vanno considerati. Intanto, il fatto che i giovani sono già oggi, e sempre più lo saranno in futuro, numericamente di meno rispetto alle coorti precedenti. A ciò si aggiungono l’aggressività della concorrenza globale, gli investimenti accessibili, l’insufficiente preparazione formativa e la non immediata disponibilità di manodopera qualificata, la complessità dei mercati e la messa in questione delle regole del gioco. Non meno decisivi, gli orientamenti valoriali degli eredi.
Da dove potrebbero arrivare nuove energie imprenditoriali capaci di raccogliere il testimone?
IMPRENDITORIA GIOVANILE
Il primo cluster a cui guardare sono le nuove generazioni. Per definizione, i giovani rappresentano una componente naturale di innovazione e rinnovamento del panorama socioeconomico e dunque imprenditoriale, grazie alla loro capacità di intercettare i cambiamenti, sviluppare nuove competenze e proporre modelli alternativi di business.
Cominciamo col considerare la scelta tra lavoro autonomo e dipendente. I dati confermano che il 48% dei giovani italiani esprime una preferenza per l’autonomia lavorativa rispetto al lavoro dipendente. Un valore più significativo rispetto al posizionamento dei coetanei francesi (33%) e tedeschi (38%), in linea con i caratteri della nostra tradizione che non vede di buon occhio l’inserimento in organizzazioni troppo strutturate.
I giovani italiani, dunque, mantengono vivo il desiderio di indipendenza, ma tuttavia resta il dubbio: questa propensione è frutto di una scelta volontaria o costituisce una risposta adattativa a un mercato del lavoro ancora rigido negli schemi e poco accessibile? Il lavoro autonomo è davvero un’opportunità per un giovane, o diventa una necessità, in uno scenario privo di alternative e supporti concreti?
A questo proposito, il dato sulla propensione all’intrapresa indica che i 18-64enni italiani mostrano una maggiore inclinazione all’imprenditorialità e all’autoimprenditorialità rispetto ai coetanei francesi e tedeschi. Inoltre, alla domanda se l’avvio di un’impresa costituisca una scelta di carriera desiderabile nel proprio Paese, le risposte dei giovani italiani portano l’Italia nella parte alta della classifica europea, dietro solo a Lituania, Romania, Cipro, Serbia e Grecia.
Piu in generale, l’Italia continua a distinguersi per la creatività imprenditoriale: solo il 15,8% dei giovani dichiara di non avere idee imprenditoriali, un valore inferiore rispetto alla Germania (21%) e alla Francia (19,8%).
L’Italia si colloca, inoltre, al secondo posto in Europa, dopo la Grecia, anche per il numero di giovani imprenditori con dipendenti. Il dato conferma che la voglia di provarci non manca. Almeno dal punto di vista dell’immaginario, la propensione imprenditivita rimane viva.
È una boccata di ossigeno che non andrebbe dissipata.
Il problema è che i giovani hanno la percezione di avere a che fare con un ambiente tendenzialmente ostile.
In effetti, quando si analizza la percentuale di persone della stessa fascia di età che vedono buone opportunità di avviare un’attività ma non procedono per paura del fallimento, l’Italia si colloca ai vertici del ranking. Anche rispetto alla percentuale di popolazione che percepisce buone opportunità imprenditoriali nel proprio territorio, l’Italia occupa la quarta peggior posizione in Europa, dopo Ungheria, Spagna e Slovacchia. Dunque, si osserva uno scarto tra lo spazio dell’immaginario (“Mi piacerebbe…”) e quello della possibilità (“Vedo delle opportunità reali…”). Sarebbe interessante capire la ragione di questo differenziale.
La difficoltà non sembra dipendere prima di tutto dal tenore del contesto economico da parte dei giovani. Solo l’11,5% dei giovani italiani, infatti, intravede un clima economico sfavorevole all’imprenditoria, mentre in Germania questa percentuale sale al 22,3% e in Francia al 14,8%.
Più rilevante appare la questione culturale: la figura dell’imprenditore fatica a essere riconosciuta socialmente, nonostante l’idea di iniziativa autonoma resti desiderabile. Alla domanda se gli imprenditori di successo godano di alto status nel proprio Paese, l’Italia si posiziona nella parte bassa della classifica, sebbene con un punteggio migliore rispetto a Francia e Spagna.
Tra i principali ostacoli che scoraggiano i giovani italiani (15-30 anni) dall’avviare un’attività imprenditoriale vengono indicati la mancanza di risorse finanziarie (41,8% in Italia, rispetto al 32% in Francia e al 37% in Germania). Seguono la scarsa fiducia degli investitori nei giovani (31,8% contro il 26,3% in Francia e il 23,1% in Germania); la mancanza di competenze e conoscenze (30,6%); le difficoltà burocratiche e amministrative (29%).
L’apertura all’intrapresa degli italiani appare dunque gelata sul nascere da un contesto generale che non risulta propriamente favorevole a coltivare i semi dell’iniziativa imprenditoriale.
Si tratta di un quadro per nulla nuovo e già ben conosciuto agli addetti ai lavori, sul quale almeno in parte si è già lavorato come avvenuto, ad esempio, con le iniziative di sostegno alle start up giovanili, sebbene insufficienti a far partire – in sé – processi su larga scala.
Eppure, lo sforzo compiuto non sembra essere sufficiente a modificare la percezione di un habitat ancora poco propenso a dare spazio e risorse economiche, infrastrutturali e simboliche, e dunque a scommettere sulle nuove generazioni. Rispetto ad altri Paesi, in Italia continua a sussistere una diffidenza, quasi un pregiudizio nei confronti delle iniziative imprenditoriali giovanili. A dire che il Paese sembra poco propenso a rischiare e a credere che il nuovo abbia a che fare anche con le visioni diverse di cui ogni generazione è portatrice.
Emerge cosi l’immagine di un Paese attardato da incrostazioni che ne bloccano il dinamismo e che rischiano di disperdere il potenziale d’intrapresa dei giovani. Può essere utile interrogarsi: dove si annidano pregiudizi e stereotipi generazionali? E perché? Come facilitare l’incontro e il passaggio tra le generazioni?
Come è logico aspettarsi, questo quadro nazionale assume poi specifiche configurazioni territoriali: l’intrapresa giovanile (18-29 anni) registra la concentrazione più elevata nel Nord (in particolare, nell’area lombarda, in quella piemontese, in particolare nel Torinese e nel Cuneese, e nelle province di Trento e Bolzano,). A seguire l’asse laziale-campano, con alcuni dinamismi al Sud, in Sicilia, Calabria e Puglia.
I dati del Rapporto evidenziano, dunque, una contraddizione: da un lato, i giovani italiani desiderano intraprendere un’attività autonoma, hanno idee e una visione sufficientemente positiva all’intrapresa; dall’altro, questi stessi giovani sono frenati dalla paura del fallimento e dalla mancanza di condizioni favorevoli. Una situazione che fa pensare all’analogia del trampolino: si sarebbe pronti a saltare, ma si teme di non trovare l’acqua in piscina.
A questo quadro si aggiunge un’altra tendenza non positiva: la crescente emigrazione giovanile. Come già evidenziato nel secondo Rapporto Italia Generativa, sono numerosi i giovani italiani che scelgono di lasciare il Paese per cercare altrove migliori opportunità di crescita e riconoscimento professionale. Un’emorragia importante che andrebbe contrastata con politiche di rientro e da iniziative di sostegno a iniziative imprenditoriali in grado di mettere a frutto e trarre vantaggio dalle esperienze internazionali accumulate.
Non da ultimo, occorre considerare il possibile impatto di quel trasferimento di ricchezza generazionale oggi atteso dalle coorti nate nel Dopoguerra che hanno attivamente partecipato alla ricostruzione del Paese e visto crescere in modo significativo livelli di vita, redditi e patrimoni. Che effetto farà nel nostro Paese questa eredità? Verrà messa a disposizione di nuova intrapresa, oppure, oltre ad accentuare le diseguaglianze interne, contribuirà a depotenziare la spinta imprenditiva a causa di un narcotizzante “effetto rendita”?
In definitiva, ciò che emerge è una chiara questione di ricambio generazionale anche per quanto riguarda la dimensione imprenditiva. Per incentivare e trovare fresche energie, appare necessario lavorare in tre direzioni:
- promuovere anche durante gli anni della formazione un nuovo immaginario sull’intrapresa favorendo l’incontro e lo scambio con testimonial propositivi;
- prendersi cura di quel germoglio imprenditoriale che senza le necessarie condizioni di clima rischia di non bucare il terreno o di seccare sul nascere;
- guardare anche altrove, ad altri possibili interlocutori, in corrispondenza di quelle trasformazioni storiche che riguardano le società evolute e che arrivano in ritardo a toccare la società italiana.
IMPRENDITORIA FEMMINILE
La ricerca di nuove spinte imprenditive porta innanzitutto a guardare alle donne, storicamente più marginali rispetto al protagonismo maschile e oggi con livelli di educazione formale più elevati rispetto ai coetanei maschi.
Secondo l’OCSE/UE, a livello europeo si osserva una riduzione del gender gap nell’imprenditoria, sebbene le donne abbiano ancora il 40% in meno di probabilità rispetto agli uomini di avviare un’attività lavorativa.
Anche in Italia, le donne partecipano sempre di più al mondo dell’impresa, ma restano ancora sottorappresentate rispetto al loro potenziale. Se il percorso imprenditoriale è complesso per gli uomini, lo è ancor più per le donne, che devono affrontare barriere culturali, sociali e una minore accessibilità a finanziamenti e reti di supporto.
E tuttavia, dai dati raccolti il divario di genere resta marcato. Guardando anzitutto alla quota di lavoratori autonomi che sono anche datori di lavoro, gli uomini rappresentano il 7,5% del totale dell’occupazione nel 2023, contro il 3,6% delle donne1 Sebbene in entrambi i casi con percentuali maggiori in rapporto alle medie UE (rispettivamente 5,5% U e 2,4% D).. Anche il numero delle giovani imprenditrici (15-39 anni) senza dipendenti è poco più della metà di quello degli uomini.
Inoltre, rispetto alla quota di lavoratori datori di lavoro almeno laureati, gli uomini sono pari al 6,3% sul totale dei lavoratori, mentre le donne sono solo il 2,6%. Anche la quota di lavoratori autonomi indipendenti è pari a 15% del totale occupazione per gli uomini a fronte di un 10,7% delle donne. Anche prendendo in esame la quota complessiva dei lavoratori autonomi almeno laureati il quadro non cambia: il 25,8% sono uomini, il 17,4% donne.
In aggiunta, secondo l’indice TEA, relativamente alla percentuale di donne intervistate che sono o aspiranti imprenditrici o gestrici-proprietarie di una nuova intrapresa, divisa per la percentuale equivalente dei loro omologhi maschi, l’Italia si colloca nella parte basse della classifica europea, facendo peggio di Spagna, Francia e Germania.
Secondo alcune ricerche, una delle motivazioni principali che spingono le donne verso l’imprenditoria sarebbe proprio la difficoltà a trovare un lavoro dipendente in grado di garantire loro una migliore conciliazione tra vita professionale e familiare. Ma la di là di questa considerazione, rimane il fatto che, nonostante le misure di sostegno esistenti (formazione, coaching, accesso al credito, reti professionali), anche nel nostro Paese il cammino verso un’effettiva parità nell’imprenditoria è ancora lungo.
Nell’esplorazione di nuovi protagonismi imprenditoriali, l’universo femminile rimane ancora in larga parte sottotraccia. Anche rispetto a questo cluster, urgono policy mirate alla luce di un potenziale che, se sostenuto, potrebbe contribuire in modo significativo alla vita socioeconomica del Paese. I dati confermano come le giovani donne abbiano recuperato il gap a livello formativo rispetto ai loro coetanei maschi e stiano progressivamente colmando il ritardo anche nelle materie strettamente economiche e Stem.
Allo stato attuale dell’evoluzione della società italiana, è difficile immaginare una nuova primavera imprenditoriale che prescinda dalla componente femminile. E su questo punto bisogna lavorare con politiche specifiche, anticipando l’intervento già a partire dagli anni della scuola superiore e dell’università.
IMPRENDITORIA STRANIERA
Una terza componente da considerare è rappresentata dall’imprenditoria straniera che a livello europeo costituisce una risorsa in crescita. In tutta Europa, il numero e la qualità delle imprese fondate da imprenditori stranieri sono in aumento.
Un aspetto interessante è l’evoluzione della tipologia imprenditoriale all’interno della comunità straniera, che sta passando da modelli di autoimpiego a forme più strutturate, capaci di generare valore e occupazione. In alcuni Paesi, queste realtà stanno creando occupazione anche per i lavoratori autoctoni, con percentuali addirittura superiori rispetto agli imprenditori locali.
In Italia, il contributo imprenditoriale straniero è nettamente superiore alla media europea: il nostro paese registra il 10,4% di imprenditori esteri, contro una media UE del 3,2%. La maggior parte rientra tuttavia nell’autoimprenditorialità (autoimpiego), mentre è più raro il caso di imprese con dipendenti (è tutta via largamente superiore al dato europeo: 12,4% contro il 3,4% in UE).
Rispetto a questa specifica popolazione, ancora più difficile è la posizione delle donne che devono affrontare sfide complesse: oltre agli ostacoli burocratici e di accesso agli investimenti, permangono barriere linguistiche e minori dotazioni in termini di capitale relazionale, a causa di reti sociali più ristrette. Paradossalmente, però, per molte donne straniere l’autoimprenditorialità rappresenta l’unica via per accedere ad un lavoro e a un reddito.
Da questi dati emerge, dunque, che la componente di origine straniera è ormai parte integrante della struttura imprenditoriale italiana. Ciò richiede un’attenzione particolare sia per sostenere e alimentare questa spinta, sia per evitare i rischi associati allo sviluppo di settori di sottoimpiego e marginali, aree di lavoro che rischiano di rimanere intrappolate nel sommerso. Sappiamo, infatti, che queste ultime solo apparentemente contribuiscono allo sviluppo economico, mentre più facilmente replicano diseguaglianze ed alimentano tensioni sociali mentre producono concorrenza tra categorie di lavoratori già in sofferenza.
Il quadro presentato, più che indicare timide novità, illumina aree di potenziale inespresso: in generale per i giovani e in modo particolare per la componente femminile siamo in presenza di uno spreco umano, sociale ed economico che l’Italia non può più permettersi.
L’imprenditività – area del nuovo per eccellenza – ha bisogno del contributo di nuove forze, ma queste per poter continuare ad esistere oltre la pura propensione all’intrapresa, richiedono una visione di lungo periodo che parte dall’investimento nel capitale umano, e dunque dall’educazione e dalla formazione, per arrivare alla finanza e agli investitori; si alimenta dalle reti della conoscenza e della ricerca; si appoggia alla dotazione tecnologica e infrastrutturale; dialoga con un tessuto sociale e culturale aperto, irrorato da fiducia e coraggiosa lungimiranza.
Serve una visione d’insieme capace di lavorare in modo integrato su tutti fattori abilitanti l’intrapresa, con particolare attenzione a quelle componenti che, ancora oggi, pagano, alla partenza, un pegno doppio.
2 - ALIDLÀ DELLA DICOTOMIA PICCOLO/GRANDE
Negli anni Sessanta e Settanta, il Censis di Giuseppe De Rita contribuì a interpretare l’evoluzione di un Paese in pieno boom economico che imboccò una strada inattesa: quella del decentramento produttivo e della diffusione delle PMI. Fu la spinta imprenditoriale dal basso, infatti, a diventare il motore di una crescita economica tumultuosa, ma anche eterodossa rispetto alle principali teorie economiche del tempo.
Il grande merito dell’analisi del Censis fu quello di cogliere la dinamica profonda di una società che entrava con entusiasmo e determinazione nella sua stagione matura, mostrando una straordinaria vitalità ma anche una propria originalità e genialità.
L’Italia, infatti, è l’unico Paese in cui lo sviluppo economico del secondo Dopoguerra non si è accompagnato a una semplice crescita delle imprese esistenti, ma ha portato a un aumento significativo del loro numero.
L’interpretazione offerta dal Censis è stata però spesso contestata da chi sostiene che il problema dell’Italia è dato proprio dall’eccesso di piccole e medie imprese, considerate un vincolo alla modernizzazione del Paese. Secondo questa prospettiva, la soluzione sarebbe favorire un processo di aggregazione per creare imprese più grandi, capaci di superare i limiti di una struttura produttiva troppo frammentata.
In questo senso, il Rapporto fornisce alcuni elementi di valutazione che possono aiutare la riflessione ad andare oltre questa sterile contrapposizione, ormai superata anche dall’accresciuto fenomeno esemplare delle cosiddette “multinazionali tascabili”: imprese piccole e medie dinamiche che hanno mostrato una capacità competitiva basata non sui costi, ma sulla qualità della produzione e su un decentramento territoriale virtuoso.
Nel confronto con il panorama Europeo, l’idea che l’Italia sia un Paese fondato esclusivamente su piccole imprese appare solo parzialmente vera.
Intanto, questa caratteristica non sembra essere un’esclusiva italiana.
Osservando i dati continentali, fatta eccezione per Paesi con situazioni particolari come Lussemburgo, Svizzera, Irlanda e Olanda, il quadro dimensionale delle imprese italiane non è troppo diverso da quello di economie comparabili per popolazione e sviluppo.
Ad esempio, analizzando il numero di imprese per classi di addetti, emerge che il 94,6% delle imprese italiane sono microimprese con meno di 10 dipendenti, un valore in linea con la media europea (94,2%) e con Paesi come la Francia (96,1%) e la Spagna (94,8%). Solo la Germania presenta una percentuale significativamente inferiore (84%) e una distribuzione più bilanciata tra le varie dimensioni aziendali.
Anche il numero medio di addetti per impresa è in Italia simile a quello della Francia (4) e vicino a quello della Spagna (5) che è pari alla media europea. In questo caso, la distanza rimane significativa con la Germania, dove il valore sale a 12.
L’Italia si distingue per il numero totale di imprese. Rispetto a questo indicatore, il nostro Paese si colloca al secondo posto in Europa (4,5 mil), dopo la Francia (5 mil), e prima di Spagna (3,5 mil) e (piuttosto distaccata) la Germania (3,2 mil). Allo stesso tempo, l’Italia è prima per numero di imprese nei settori manifatturiero e commerciale.
Per trovare la specificità italiana, occorre però guardare in un’altra direzione.
Se si considera il fatturato netto, l’Italia si colloca al terzo posto (4,2 milioni di euro), dopo la Germania (marcatamente al vertice del ranking con 10,4 mil) e la Francia (5,6 mil), mentre fa meglio della Spagna (3,00).
Altro interessante indicatore è la distribuzione del fatturato netto per classe dimensionale. Dai dati emerge che in Italia le grandi imprese (oltre 250 addetti), pari allo 0,1% del totale delle imprese, generano solo il 38% del fatturato netto. In Francia, nonostante una percentuale simile di grandi imprese (0,1%) questo segmento arriva al 60%; mentre in Spagna – altra realtà non distante dalla nostra – tale valore è del 46%. In Germania, dove la quota di grandi imprese è più alta (0,4%), queste ultime generano il 63% del fatturato.
Per quanto riguarda il valore aggiunto, l’Italia è terza in Europa con 1,1 milioni di euro, dopo la Germania (2,9 milioni) e la Francia (1,5 milioni).
Più che la sola dimensione delle imprese, il modello italiano sembra dunque essere caratterizzato dai seguenti elementi chiave:
- maggiore contributo delle microimprese. In Italia, il contributo delle imprese sotto i 10 addetti (94,5% del totale) concorre per un 23% al fatturato netto totale, contro un 16% della medesima fascia dimensionale francese (pari a 96,1%) (tabella 3.2). Allargando la prospettiva e classi dimensionali, in Italia, le imprese con meno di 50 dipendenti contribuiscono per oltre il 40% al fatturato netto, contro il 28% della Francia, il 37% della Spagna, e il 23% della Germania. Guardando al fatturato netto per addetto, l’Italia supera Francia e Germania nelle classi 10-19, 20-49 dipendenti. Anche il valore aggiunto per classe di addetti segnala il 26% delle imprese italiane, contro un 16% di quelle francesi. (tabella 5.1). Nuovamente, in sintesi, il valore aggiunto apportato dalle imprese sotto i 50 dipendenti è pari al 45% in Italia e al 32% in Francia e Germania;
- forte presenza di medie imprese industriali. Guardando al fatturato netto per addetto, l’Italia supera Francia e Germania anche nella classe 50-249 dipendenti. Come mostra la letteratura economica, lo sviluppo delle medie imprese italiane – che garantiscono gran parte della capacità di export del nostro Paese – è in larga parte il risultato dell’evoluzione dei distretti industriali. Si tratta di un segmento di grande rilevanza economica e strategica che ha dimostrato, in presenza di talune condizioni, di sapersi evolvere ulteriormente, come conferma la “metamorfosi del modello emiliano”. I principali elementi che connotano questo particolare sviluppo sono: l’irrobustimento delle dimensioni delle imprese; la spiccata apertura internazionale; il convinto investimento nel fattore umano e in conoscenza; la capacità di infrastrutturare il contesto con reti fiduciarie e collaborative, oltre che con buone relazioni territoriali; il potenziamento delle specializzazioni di artigiania industriale e tecnologiche; la scelta chiara verso il miglioramento continuo della qualità di prodotti e servizi (innovazione) versus quantità (volumi); un dialogo convergente e fattivo tra sfera privata e sfera pubblica. In questo “modello” la vocazione imprenditiva e la ricerca della coesione sociale sono diffuse, la media impresa emergente è in grado di catalizzare e fare da traino a un sistema più ampio di filiera;
- scarsa presenza di grandi imprese. Storicamente, in Italia le imprese di grandi dimensioni sono state di proprietà statale ed attive in settori strategici come chimica, siderurgia ed energia, dove era necessaria una forte concentrazione di capitali per investimenti infrastrutturali. Nonostante l’ondata di privatizzazione degli anni Novanta, questo modello si conferma ancora oggi come tipico del nostro Paese. Di fatto, la globalizzazione ha colpito più le grandi imprese private italiane che le PMI. La ragione di questo risultato sta nel fatto che molte grandi imprese hanno puntato più su risultato finanziario che su quello industriale, con una conseguente riduzione della qualità e quantità del capitale investito. Il risultato è che, dal 1991 al 2016, il fatturato delle grandi imprese pubbliche italiane è passato da 75 a 150 miliardi di euro, mentre quello delle grandi imprese private è sceso da 55 a 29 miliardi. Questo calo è dovuto anche alla delocalizzazione: alcune aziende hanno scelto di trasferirsi all’estero, attratte da incentivi economici e fiscali, mentre altre sono state acquisite da gruppi stranieri. A parte le imprese private italiane, anche le estere segnalano delle difficoltà: l’investimento in Italia viene sospeso spesso a causa dell’assenza di un milieu favorevole giurisprudenziale e burocratico.
Il tessuto imprenditoriale italiano costituisce dunque un ecosistema articolato, caratterizzato da varietà dimensionale (dove convivono micro, piccole, medie/grandi imprese); pluralità settoriale (manifatturiero, servizi, agroalimentare); radicamento territoriale (sviluppo distrettuale, realtà urbane vs. periferiche). Questa particolare configurazione ha indiscutibili punti di forza, ma al tempo stesso vede diversi punti di fragilità strutturale, alcuni di questi già ben conosciuti in quanto derivanti dalla elevata frammentazione, dal passaggio di testimone dall’industria ai servizi – sebbene il sostrato manifatturiero resista e sia ancora solido –, dalla scarsa propensione a investire soprattutto da parte delle imprese piccole e micro. Un’incertezza che rimanda alla morfologia della struttura produttiva, ovvero se le imprese di questa fascia continueranno a esprimere soggetti imprenditoriali capaci di irrobustirsi ulteriormente. Con tutto le preoccupazioni che è legittimo avere tenendo conto delle forti tensioni geopolitiche e dell’instabilità del quadro macroeconomico globale.
Oggi, in particolare, tra le questioni con cui si trova a fare i conti ci sono:
– bassa produttività. In termini di produttività del lavoro corretta per i salari, l’Italia è al di sotto della media UE (149,4% contro 152,6% EU). Le conseguenze della bassa produttività sono importanti per la capacità del Paese di crescere e mantenere il livello di vita ottenuto nei decenni passati;
– bassi salari. Questo dato ha una triplice spiegazione. In primo luogo, il forte carico fiscale che pesa sul lavoro (parliamo di oneri sociali a carico del datore di lavoro che in Italia raggiungono il 27,6% delle retribuzioni, mentre la media EU è pari al 21,8%; in Francia sono i 28,3% mentre in Germania sono al 19,4%) che comprime le disponibilità economiche per sostenere gli stipendi. In secondo luogo, la tendenza a una redistribuzione delle risorse dal lavoro al capitale che si registra in Italia come in altri Paesi. Infine, la sopramenzionata bassa produttività che da un lato, comporta l’impossibilità di distribuire ricchezze e dall’altro persiste proprio in ragione dei bassi salari che costituiscono un’alternativa all’investimento in nuove tecnologie e nuovi modelli organizzativi;
– vulnerabilità di un modello centrato sulle medie imprese altamente competitive. La forte instabilità geopolitica rischia di mettere a repentaglio i risultati ottenuti. Tanto più che la virtuosità della parte esportatrice del modello economico italiano non è allineata con il forte indebitamento pubblico e la più generale scarsa produttività del Paese. È come se ci fossero due Italie che hanno ben poco a che fare l’una con l’altra, dove la prima in larga parte sostiene la seconda;
– limitata stabilità finanziaria. Da uno sguardo complessivo, la recente riduzione dei tassi di interesse fornisce un impulso positivo all’economia. Tuttavia, la redditività delle imprese ha mostrato segni di peggioramento, e stabile è risultato il credito erogato rispetto allo scorso anno (+0,9%) con una lieve crescita in termini di importi (+2,4%) nonostante gli aumentati costi di finanziamento. La capacità delle imprese di rimborsare i debiti è restata mediamente buona, e il tasso di deterioramento dei prestiti bancari si è confermato contenuto2 Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2 – 2024; mentre il tasso di default medio delle società di capitali è stimato a fine 2024 in leggero incremento sull’anno precedente (+2,9%)3 CRIF, Osservatorio sulle imprese, febbraio 2025. Questo scenario evidenzia una fragilità strutturale, che ostacola gli investimenti e le strategie di lungo periodo. Sul sistema finanziario italiano si è scritto molto, in particolare a proposito di un modello “banco-centrico”. Anche in relazione ai processi di verticalizzazione in atto, il tema dell’accesso alle risorse finanziarie merita di essere considerato con attenzione, in rapporto alle caratteristiche intrinseche dell’imprendività Italiana. Anche i dati relativi alle imprese sociali del nostro Paese rilevano un quadro finanziario fragile; il 68% delle imprese sociale dichiara di avere un orizzonte di sostenibilità finanziaria di soli 12 mesi; il 16% circa una sostenibilità inferiore ai 3 mesi; solo il 7% circa afferma di avere una prospettiva superiore ai 24 mesi.
In realtà, la polarità piccolo/grande racconta molto di più di quello che si è soliti pensare. Essa nasconde in sé la tensione di fondo tra standardizzazione e scalabilità da un lato, e varianza e innovazione, dall’altro; o tra globalizzazione da un lato, e radicamento locale dall’altro.
Il modello italiano si caratterizza per la forte presenza di una élite con matrice industrialista impegnata a enfatizzare le condizioni peculiari delle competenze locali; che anima un’imprenditorialità vigorosa e un’economia intermedia operante secondo logiche di filiera, lascito di una lunga storia di creative produzioni artigianali.
La gestione di questa tensione non è mai stata facile per il nostro Paese che ha dimostrato di non essere a misura delle grandi imprese. E non lo è tutt’oggi.
Tale tensione ruota attorno a tre elementi chiave, peraltro scarsamente compresi e persino conosciuti nel dibattito sull’impresa Italia a:
- tecnodiversità, ovvero la capacità dell’imprenditoria italiana di integrare diverse tecnologie e molteplici approcci innovativi;
- neghentropia, cioè la capacità di contrastare i processi di disordine e decadimento attraverso la generazione di valore sostenibile nel tempo, rendendo riflessiva la produzione e l’uso delle conoscenze da cui possono derivare inediti stati di ordine;
- ecosistemicitá, come creazione di un contesto favorevole in grado di supportare la crescita e l’innovazione delle imprese, indipendentemente dalla loro dimensione.
É riconoscendo e valorizzando questi tre fattori e facendoli interagire strategicamente tra loro che è possibile superare il rischio di rimanere bloccati in una contrapposizione che non porta di nessuna parte. La sfida è aprire nuovi immaginari sull’impresa e disegnare scenari di sviluppo per una imprenditività che paga la fatica di sviluppare una visione binoculare – universale e insieme particolare – come è del resto l’anima più profonda del Paese.
3 - TECNODIVERSITÀ: L’IMPRESA ITALIANA DAVANTI ALLA SFIDA DIGITALE E ORGANIZZATIVA
La digitalizzazione rappresenta il nuovo ambiente tecnologico in cui si svolge l’attività imprenditoriale. Comprendere il posizionamento dell’Italia nella transizione digitale è dunque cruciale per valutare le sfide e le opportunità future.
Rispetto a questa transizione, l’Italia si caratterizza per la presenza di luci e ombre.
Sul fronte della digital intensity, ovvero la diffusione di tecnologie digitali di base tra le aziende, l’Italia si colloca sopra la media UE, subito dietro la Germania e davanti alla Francia.
Tuttavia, il quadro cambia radicalmente se si considera l’adozione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale (AI). In questo ambito, i dati raccontano di un’Italia è molto distante dai Paesi leader del ranking, come Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi, ma anche dalla Germania, che, pur essendo più vicina al nostro posizionamento, registra livelli di adozione significativamente superiori.
Ancora più fosca è la prospettiva a cinque anni: oltre il 50% delle aziende italiane dichiara che non utilizzerà l’AI, o che il suo impatto sulle attività aziendali sarà irrilevante. Inoltre, un ulteriore 9% non ha espresso alcuna previsione, segno di una mancanza di visione strategica in questo ambito. Ad oggi, l’impiego delle tecnologie emergenti rimane particolarmente basso nel nostro Paese, evidenziando un certo ritardo nella capacità di analisi avanzata delle informazioni.
Anche sul fronte dell’e-commerce, l’Italia si colloca al di sotto della media UE per numero di aziende che lo utilizzano. Tuttavia, in termini di fatturato derivante dal commercio elettronico, il Paese si avvicina alla media europea. Questo suggerisce che un’adozione più ampia delle transazioni via Internet potrebbe portare a un incremento significativo dell’attività commerciale. Al momento, però, il numero di imprese italiane in cui l’e-commerce genera almeno l’1% del fatturato resta molto basso.
Infine, per quanto riguarda l’export di prodotti ad alto contenuto tecnologico, l’Italia registra un valore di 83,25 secondo l’indicatore EIS, costruito ponendo la media UE del 2016 pari a 100.
Questo dato indica una performance inferiore rispetto alla media europea attuale (99,33) e a economie come la Germania (112,03) e la Francia (86,75), segnalando una minore competitività del Paese nel settore high-tech rispetto ai principali partner europei.
Questi dati mostrano un’Italia con buone basi digitali, ma in ritardo sull’adozione di tecnologie avanzate e sull’evoluzione del commercio digitale. Dato che non deve stupire tenuto conto che per quanto riguarda gli investimenti nelle PMI l’Italia si trova a metà classifica, dietro a Francia e Germania (top performer: Finlandia, Svizzera).
Ma aldilà del dato puramente quantitativo, la questione digitale va considerata dal punto di vista qualitativo. Per l’Italia, questa transizione costituisce, infatti, una sfida particolarmente impegnativa, poiché le nuove tecnologie digitali posseggono un forte potere di standardizzazione e burocratizzazione. Da questo punto di vista, non si riduce alla capacità delle imprese italiane di adottare le nuove tecnologie digitali (condizione necessaria) ma implica la capacità delle stesse imprese di utilizzare tali tecnologie per rafforzare quelle specificità che sono allo base anche dell loro successo.
Il pluralismo digitale è una risorsa essenziale, ma rappresenta anche un potenziale rischio per un modello italiano basato sulla tecnodiversità. Con questo termine si intende la capacità non solo di adottare o conservare una tecnologia, ma di personalizzarla e manipolarla in base a quella “cosmologia” – da intendersi come un insieme di fattori generativi come lingua, cultura, visione del mondo, tradizione, sensibilità artistica, professionalità e modelli organizzativi – che, guidando il divenire, conferisce un vantaggio competitivo.
La tensione del rapporto piccole e medie e grandi imprese sopracitata sta tutta qui. L’Italia, infatti, non è semplicemente una terzista di altri Paesi. Piuttosto, il sistema imprenditoriale italiano si è storicamente distinto – e continua a distinguersi – per la sua capacità di gestire in maniera originale ed efficace la disponibilità tecnologica di ogni tempo.
Ciò molto concretamente significa che lo specifico del mondo delle piccole e medie imprese italiane deriva dalla sua capacità di una artigiania che gli altri paesi non riescono a raggiungere, ovvero di quella attitudine manipolativa della tecnologia che, creando contesti lavorativi peculiari, riesce a generare un vantaggio competitivo.
Questa tematica è particolarmente rilevante in un momento in cui la digitalizzazione, da un lato, introduce un ulteriore livello di standardizzazione, ma dall’altro può aprire nuove possibilità di variazione e innovazione.
Se proviamo a trarre un’indicazione da quanto è accaduto con precedenti ambienti tecnologici, l’Italia ha sì un problema di raggiungere una familiarità con la nuova tecnologia e la disponibilità di infrastrutture e professionalità adeguate, ma anche la possibilità di riuscire a non sottomettersi a rigidità logiche che tenderebbero a distruggere il patrimonio della specificità italiana.
La chiave di volta della tecnodiversità ha prima di tutto a che fare con i modelli organizzativi, oltre che con quelli formativi. Per questa ragione è utile guardare alla transizione digitale considerando quanto sta accadendo nel mercato del lavoro, sia dal lato della domanda che dell’offerta.
Accanto al noto mismatch delle competenze – il divario tra le competenze richieste e quelle effettivamente disponibili sul mercato – si è andato aggiungendo negli ultimi anni un crescente skill shortage, dovuto alla scarsità di persone disponibili a entrare nella forza lavoro. Le cause sono molteplici: il cambiamento demografico; le scelte delle nuove generazioni che vedono maggiori opportunità all’estero rispetto all’Italia; un sistema retributivo poco competitivo; la debole efficacia delle politiche di conciliazione.
I dati confermano le difficoltà nel reperire personale qualificato: ben il 69% delle imprese dichiara di incontrare molta o abbastanza difficoltà nella ricerca di figure professionali adeguate. Inoltre, i tempi di reclutamento non sono sempre rapidi. Le cause principali della difficoltà nel reperire personale, secondo le aziende italiane, sono la mancanza di conoscenze e competenze adeguate nei candidati (57%), ma anche la scarsità o perfino l’assenza di candidati disponibili (54%).
Questa situazione ha un impatto significativo sulle imprese. Tra le conseguenze principali vengono segnalate: sovraccarico di lavoro sul personale disponibile; aumento dei costi di produzione; mancate vendite o problemi di espansione commerciale.
Per fronteggiare questo problema, le aziende stanno adottando alcune strategie, tra le quali il miglioramento delle condizioni di lavoro – leva importante che contribuisce a rendere queste aziende più attrattive per la forza lavoro, specie quella qualificata –; l’investimento nell’upskilling e reskilling del personale; l’ampliamento dei canali di reclutamento (social media, piattaforme digitali, advertising); l’utilizzo di lavoratori temporanei o autonomi.
Tuttavia, il tasso di coinvolgimento dei lavoratori nelle attività imprenditoriali vede l’Italia in posizione intermedia. Eppure, un maggiore coinvolgimento potrebbe favorire una cultura dell’intrapresa, allargando gli spazi per l’iniziativa e l’innovazione. Su due aspetti chiave – rilevati dalle analisi sulle scelte delle imprese sociali – emergono chiari margini di miglioramento: il coinvolgimento dei beneficiari nelle decisioni aziendali (l’Italia è sotto la media ESEM, superato da Turchia, Lituania, Svezia, Estonia e Portogallo); e la partecipazione dello staff alle decisioni aziendali (anche qui l’Italia si colloca a metà classifica, lontana dai primi tre Paesi Svezia, Turchia, Estonia).
Migliorare questi aspetti potrebbe favorire una cultura più aperta alla partecipazione e all’innovazione, incentivando processi imprenditoriali più efficaci e dinamici4 F. Mosconi, Modello Emilia. Imprese innovative e spirito di comunità, Posteditori, 2023.
I dati5 Si ricorda che i dati raccolti datati 2023 si riferiscono al 2022. , dunque, non appaiono particolarmente confortanti per il nostro Paese sia per quanto riguarda l’ingresso nel mondo digitale, sia per quanto riguarda i modelli organizzativi. Gli elementi di confronto internazionale mostrano alcune debolezze del nostro Paese.
Almeno in parte, la ricerca qualitativa contribuisce a correggere queste indicazioni negative. Le imprese studiate si rivelano, infatti, assai capaci di rigenerare la tecnodiversità base del modello socioeconomico italiano a partire da un convinto investimento nelle persone, nei loro talenti e nelle loro competenze, sia direttamente – ad esempio sul fronte della formazione – sia indirettamente – agevolando quelle condizioni di base che consentono un coinvolgimento reciproco tra persone e imprese, più soddisfacente e di più lungo termine; così come gli interventi sul fronte della conciliazione tra vita professionale e familiare, sul tema salute o della casa raccontano.
Ciò ci dice che continua a esistere un gruppo anche relativamente nutrito (ma certamente ancora minoritario) di imprese capace di affrontare la transizione digitale senza perdere, anzi, rafforzando quella specificità che rende forte l’impresa Italia. Purtroppo, questo non riguarda l’intera popolazione imprenditoriale.
Il problema è quello di estendere a tutto il tessuto imprenditoriale queste attitudini, contrastando la tendenza (che ritorna sempre nel nostro sistema economico) a ripiegarsi, vuoi nella direzione di un progressivo sfruttamento delle risorse umane e tecniche con la riduzione degli investimenti e lo scarso investimento nei modelli organizzativi, vuoi nell’incapacità di ragionare in termini sistemici e di rete, adottando strategie competitive e/o di collaborazione con altri player nel lungo periodo. Un’altra polarizzazione tutta italiana che impedisce di coniugare spinta all’innovazione e “spirito di comunità” ingredienti che appaiono decisivi nell’immaginare lo sviluppo del Paese.
Un’ultima questione ha a che fare con il necessario processo di managerializzazione che sta interessando un numero crescente di imprese Italiane, anche in rapporto al ricambio generazionale di molte piccole e medie imprese. Ancora una volta, occorre andare al di là di una sterile contrapposizione tra la figura eroica dell’imprenditore e quella d’ordine del manager. Tale contrapposizione che si nutre di luoghi comuni ma anche di culture improprie costituisce un blocco da superare.
La chiave per andare oltre ha che fare con quanto emerge dai dati: il sistema delle imprese italiano ha bisogno di fare un salto nella sua qualità organizzativa, obiettivo che può essere raggiunto anche grazie al contributo di manager esperti. Ma ciò a condizione che la competenza manageriale non sia giocata nel senso di una normalizzazione del modello d’impresa italiano. Ma piuttosto come elemento in grado di superare i limiti legati all’eccessiva personalizzazione dell’esperienza imprenditoriale. Un passaggio particolarmente importante, tenendo conto del tema della transizione generazionale che interessa molte imprese del nostro Paese.
4 - L’IMPRESA E IL TERRITORIO: VERSO ORGANIZZAZIONI NEGHENTROPICHE
L’impresa italiana ha una tradizione di forte radicamento nel proprio territorio di appartenenza. La scarsa presenza di grandi imprese, il ruolo dei distretti industriali e la centralità delle piccole e medie imprese (PMI) sono elementi che hanno sempre legato le organizzazioni produttive al loro territorio di origine.
Dove il modello funziona, troviamo reti di interdipendenze geografiche di breve raggio che favoriscono collaborazioni locali; elevata flessibilità e capacità di risposta rapida alle esigenze del mercato, condivisione di competenze qualificate e innovazione attraverso modelli di collaborazione win-win, supporto finanziario integrato, che rafforza la resilienza delle imprese.
Lungo questa via il modello italiano ha sempre rifuggito l’eccesso di standardizzazione in favore di una forte biodiversità imprenditoriale che costituisce un elemento di ricchezza e di varietà fondamentale.
A questo schema tradizionale, le ultime trasformazioni aggiungono alcuni elementi interessanti.
In primo luogo, la nascita e lo sviluppo dell’impresa sociale. Si tratta di una novità del panorama dell’imprenditività italiane e che conferma e rinnova la tradizionale attenzione nei confronti del contesto circostante e dei suoi equilibri sociali.
I dati su questa realtà imprenditoriale in Italia sono eloquenti: l’Italia è il Paese con il maggior numero di forme giuridiche per l’impresa sociale (15), davanti a Polonia, Germania e Austria; il 43,2% delle risorse proviene da attività commerciali (secondo posto in Europa dopo la Svizzera; il 51,1% ha un modello di finanziamento ibrido.
Tra le forme più diffuse emergono le organizzazioni non profit e le startup innovative a vocazione sociale, un modello unico nel panorama europeo, caratterizzato da dinamismo e capacità di innovazione di processo e tecnologica. Questo settore rappresenta un universo di imprenditori e imprenditrici che contribuiscono attivamente alla generazione e redistribuzione del valore, confermando il ruolo centrale dell’imprenditività sociale nell’economia italiana.
La biodiversità imprenditoriale – intesa come varietà di settori, obiettivi economici, e forme giuridiche che valorizzano le specificità e le diversità di ciascun soggetto – costituisce senza dubbio una ricchezza che va salvaguardata e alimentata. Essa accresce il territorio di risorse di natura diversa, contribuendo allo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale maggiormente resiliente e inclusivo.
In secondo luogo, la matrice territoriale delle imprese italiane si traduce in una spiccata attenzione verso la sostenibilità ambientale. Ben il 45% delle aziende italiane ha dichiarato di non aver riscontrato particolari problemi nella transizione energetica.
Sul tema ambientale, l’Italia si conferma ben posizionata, collocandosi nella parte alta dei ranking di settore. Alcuni esempi: il nostro Paese si distingue per l’elevato numero di imprese che hanno adottato misure per ridurre l’uso di carta ed energia in relazione alle attrezzature ICT (70%, superiore alla media UE); nelle scelte di acquisto nel settore ICT, l’Italia si posiziona seconda in Europa, dopo il Portogallo; anche rispetto alle iniziative di riciclo ICT, il nostro Paese supera ampiamente la media UE.
Un modello economico di produzione e consumo particolarmente rilevante è quello dell’economia circolare, in cui l’Italia si colloca al quarto posto per investimenti privati (12.423 milioni di euro), anche se distanziata da Regno Unito (33.722 milioni) e Germania (31.507 milioni). In rapporto al PIL, l’Italia registra lo 0,7%, leggermente sotto la media UE (0,8%).
Per quanto riguarda il valore aggiunto generato dalla circular economy, l’Italia è terza in Europa (43.646 milioni di euro), pur restando ancora lontana da Germania (79.000 milioni) e Regno Unito. Tuttavia, il settore impiega il 2,4% della forza lavoro italiana, una percentuale significativamente superiore a quella tedesca (1,7%).
Nonostante questi risultati, il numero di brevetti e innovazioni nel settore non sembra essere all’altezza dell’impegno complessivo: 0,36 brevetti per milione di abitanti, contro una media UE di 0,46 e un dato tedesco di 0,55. Sebbene l’88% delle imprese italiane dichiari di aver intrapreso iniziative per la sostenibilità, gli investimenti finanziari per l’efficientamento delle risorse energetiche restano inferiori rispetto ad altri Paesi. Solo il 27% delle imprese ha destinato tra l’1% e il 5% del turnover a questi investimenti.
Si tratta di tendenze che possono essere considerate irreversibili, soprattutto se si considera che quasi l’80% dei giovani italiani considera l’impegno sociale e ambientale dell’impresa un criterio rilevante nella scelta lavorativa.
Inoltre, l’Italia si colloca tra i primi cinque Paesi in cui i giovani ritengono che la tutela delle persone debba essere una priorità per le aziende, segnando un cambiamento di sensibilità e valori, in particolare tra le nuove generazioni.
I segnali emergenti dall’analisi quantitativa vengono confermati anche dalla ricerca qualitativa, la quale consente di mettere a fuoco le logiche e le pratiche di un profilo di impresa che potrebbe segnare lo sviluppo imprenditoriale italiano dei prossimi anni.
Le indicazioni emergenti dalla ricerca suggeriscono che è in atto una metamorfosi nel rapporto tra l’impresa e il territorio che, se da una parte conferma lo stretto legame esistente (che le stesse imprese considerano vitale), dall’altra ne mette in evidenza i nuovi caratteri.
Si può parlare a questo proposito di “imprese neghentropiche” per indicare quei nuovi modelli imprenditoriali consapevoli del fatto che, per la loro stessa prosperità, sia imprescindibile perseguire un percorso di crescita che riduca gli effetti entropici dei processi economici. Una modalità che, da un lato, riguarda la vita interna delle stesse imprese attraverso l’adozione di strategie e politiche organizzative più evolute e una più ricca biodiversità imprenditoriale, e, dall’altro, la relazione con i propri interlocutori e l’ambiente sociale e naturale circostante.
Le interviste raccolte raccontano di imprese che, spesso a fronte di questioni più ampie ed esterne dell’organizzazione stessa, sono in grado di mobilitare e orientare intelligenze e risorse per immaginare e realizzare innovazioni capaci di generare valore multiforme – economico, sociale, culturale ed istituzionale – in grado di rilasciare effetti su molteplici piani per molteplici stakeholder. La logica è dialogica, connettiva e contributiva. L’approccio è integrale e dal respiro di medio-lungo periodo.
È interessante notare come, nei casi presi in esame, non si tratta mai di iniziative reattive o estemporanee. Piuttosto, i racconti restituiscono sperimentazioni inquadrabili dentro una precisa strategia di crescita e sviluppo del business. Nate da riflessioni più larghe che non raramente trovano ispirazione nella propria tradizione imprenditoriale, quasi un imprinting che ancora oggi permane e continua a rilasciare significati e orientamenti, queste stesse iniziative possono però essere avviate anche da nuove figure professionali e sociali in grado di interpretare l’intrapresa come via per coniugare, oggi, l’azione neghentropica con l’obiettivo decisivo della sostenibilità.
Il Rapporto, dunque, segnala una evoluzione importante in corso: il tradizionale modello della piccola e media impresa italiana radicato sul territorio si va trasformando in un modello più consapevole, che assume la sostenibilità economica e sociale non come vincolo formale, ma quale scelta strategica per rimanere competitivo e interpretare la tradizione imprenditoriale italiana in modo innovativo. Il contrasto all’entropia – come processo di frammentazione e dedifferenziazione che mina le stesse basi della crescita – costituisce uno scopo di cui le imprese più avvertite sono ben consapevoli. A differenza di quanto accadeva in passato, oggi non è possibile perseguire una crescita economica duratura se non ci si preoccupa di ricostruire le condizioni sociali e ambientali che la rendono possibile.
Sebbene non rappresenti ancora la maggioranza dell’imprenditoria italiana, questa linea di azione è perseguita con grande convinzione da parte di un’avanguardia imprenditoriale e manageriale dinamica, lucida e coraggiosa, che sta segnando nei fatti la linea del futuro del modello italiano.
5 - LA CURA DELL’ECOSISTEMA
La terza dimensione da considerare nella tensione tra grande e piccola taglia è quella ecosistemica, una componente imprescindibile per le caratteristiche del tessuto produttivo italiano solidamente radicato con i propri territori d’elezione, anche alla luce degli evidenti errori compiuti a livello epistemologico ormai ampiamente superati dagli studi sulla complessità (l’idea dell’impresa come entità a sé che fa per sé).
Ogni economia avanzata – e ancor più in Italia con le sue caratteristiche peculiari – va infatti considerata come un insieme che vive e prospera grazie alla sua biodiversità interna; alla cura degli equilibri che costruisce tra le diverse tipologie di soggetti; e grazie alle relazioni che è in grado di tessere con l’ambiente circostante in cui è inserito.
L’idea tradizionale dell’impresa come realtà chiusa, autodefinita e autonoma rispetto a ciò che la circonda è sempre più fuorviante e inadeguata. In un contesto di sfide globali interconnesse, con sistemi economici funzionalmente interdipendenti – e nel caso italiano particolarmente articolati e centrati sulla micro e piccola media impresa – la crescita del sistema imprenditoriale nel suo insieme dipende dalla capacità di creare un ambiente integrato e coeso, capace di alimentare l’imprenditorialità diffusa, di accelerarne lo sviluppo, di massimizzarne l’impatto.
Un ecosistema imprenditoriale virtuoso non si esaurisce con la mera presenza di aziende capaci di comportamenti positivi di business. Esso richiede un’armonia tra istituzioni pubbliche e private, regolamentazioni burocratiche efficienti, un sistema formativo evoluto e qualificato, un accesso al credito plurale e semplificato, infrastrutture connettive moderne, affidabili e sicure, reti collaborative in grado di far circolare e redistribuire opportunità, conoscenza, risorse, fiducia. Solo attraverso queste sinergie è possibile trasformare idee in azioni concrete e liberare il potenziale imprenditoriale.
Questa complessità, quando non è governata, rischia fatalmente di tradursi in frammentazione, ampliando il senso di caos e di carenza di leadership, da un lato, ma anche lo spreco di energie dall’altro.
Oggi più che mai, la sopravvivenza delle imprese dipende da un supporto integrato che coniughi efficienza urbana, educazione avanzata, infrastrutture digitali e sicurezza giuridica. Senza interventi mirati, non solo si ostacola la crescita, ma si mette a rischio la tenuta stessa del capitale imprenditoriale nazionale.
L’analisi comparativa con i principali Paesi UE rivela alcuni ritardi strutturali.
Anzitutto, l’Italia è ultima in Europa per disponibilità di capitale proprio e di debito per le PMI, superata da Francia e Germania.
In secondo luogo, per quanto riguarda le politiche di sostegno, il nostro Paese è lontano dalle eccellenze (Lituania, Finlandia), anche se supera Germania e Spagna.
In terzo luogo, anche per quanto riguarda la qualità dei programmi per le PMI, il risultato dell’Italia non è soddisfacente, sebbene migliore di un Paese come la Spagna.
A conferma di quanto viene ripetuto da anni, l’Italia è ancora il secondo peggior sistema UE per quanto riguarda gli ostacoli burocratici e pressione fiscale (peggio di noi fa solo la Spagna).
In termini generali, il sistema Italia è tra i cinque Paesi meno efficaci, con un posizionamento molto distante da Germania, Francia e Nord Europa.
Su questi temi, di cui si parla da tempo, i risultati sono ancora deludenti e le conseguenze non possono non pesare sul sistema delle imprese.
Un ritardo analogo si registra sul nodo infrastrutture, rispetto al quale l’Italia si posiziona nella parte bassa della classifica europea, pari alla Germania, ma dietro a Francia e Spagna.
In definitiva, il Paese continua a disporre di un patrimonio imprenditoriale vitale, ma in un contesto ecosistemico che appare ancora ampiamente disorganizzato e ricco di lacune e incongruenze.
Per rafforzare la propria capacità competitiva, l’Italia ho bisogno di un piano integrato che agisca in modo armonico su sei leve:
- semplificazione burocratica e riduzione del cuneo fiscale;
- accesso al credito con strumenti innovativi (fondi garantiti, venture capital);
- rafforzamento R&D attraverso partnership pubblico-private;
- formazione avanzata con focus su competenze digitali e gestionali;
- infrastrutture abilitanti (logistica, banda ultralarga, energia verde);
- reti collaborative tra università, imprese e startup.
Solo un ecosistema solido, interconnesso e proiettato sull’innovazione può garantire alle PMI italiane di esprimere il proprio potenziale, trasformando le criticità attuali in opportunità per una crescita sostenibile e inclusiva.
Per essere in grado di poter accedere alle potenzialità della transizione globale, l’Italia ha bisogno di evolvere verso un sistema più coeso e dinamico, orientato all’innovazione, alla sostenibilità e alla competitività internazionale.
6 - IL SEGNO CHE RIMANE. ALLA RICERCA DEL NUOVO SPIRITO DEL CAPITALISMO ITALIANO
Il giro di boa che i rapidi cambiamenti geopolitici e tecnologici stanno imponendo mette l’limpresa italiana davanti a un crocevia epocale: come far transitare un patrimonio unico di valori che rischia di opacizzarsi se non rigenerato alla nuova fase storica che si va formando davanti ai nostri occhi?
La storia ci consegna un modello distintivo – creativo, umanistico, radicato nei territori – che ha fatto della qualità relazionale e della bellezza il suo tratto identitario. Un sistema che è prosperato grazie alla sua capacità di sviluppare una propria specificità produttiva (tecnodiversità), di mantenere una relazione vitale col territorio (neghentropia), nel quadro di una cura ecosistemica che ha sempre garantito una ricca biodiversità.
Oggi però questo DNA rischia di subire le implicazioni negative derivanti dal combinato disposto tra ipercompetizione globale, declino demografico e riduzione del dinamismo imprenditivo.
La via da percorrere è quella di valorizzare gli elementi distintivi del nostro modello economico senza indulgere nella retorica della “buona differenza”, ma lavorando attivamente per correggere i fattori distorsivi e ostativi che possono impedire quella metamorfosi di cui oggi c’è bisogno.
Il capitalismo italiano possiede anticorpi preziosi che vanno riscoperti e declinati in chiave contemporanea:
- l’umanesimo operativo
- la creatività sistemica
- il glocalismo virtuoso
- la resilienza generativa
L’umanesimo operativo costituisce un asset fondamentale nel quadro delle evoluzioni in atto. Parliamo della capacità di valorizzare e far interagire l’intelligenza relazionale e contestuale con la manualità esperta per mettere al mondo cose nuove, belle, efficaci e sostenibili in grado di rispondere ai bisogni delle persone. Una capacità che emerge con forza dalle interviste raccolte, le quali rimandano all’attitudine dell’impresa italiana di trovare nel “mettersi al servizio” delle persone e dei loro bisogni l’energia motivante e di senso. Esemplari, a questo riguardo, sono le interviste a CAIMI o al Gruppo Magister.
Fondamentale è anche la creatività sistemica. Parliamo della fusione tra l’artigianalità estetica e l’artigiania tecnica, un sapere che fonda la straordinaria tecnodiversità del Paese. Ciò si sviluppa all’interno di una cosmologia che attraversa territori diversi è che funziona da stimolo che rende possibile quella creatività che rimane il segno distintivo del nostro Paese. Che sa ragionare in maniera transettoriale e sistemica, facendo dialogare e coniugando in modo originale materiali, strumenti, risorse, conoscenze, abilità. L’esperienza di ELICA, che alimenta l’innovazione a partire dall’incrocio con l’arte moderna, o di INDITEX, che fa della fragilità umana un’occasione di potenziamento delle competenze organizzative, sono begli esempi di creatività sistemica. Creatività sistemica è anche la ricerca della “lavoro ben fatto” che nel rispondere di criteri plurimi di funzionalità e di efficacia, di bellezza e di eticità, è riconosciuto nel mondo nel label “Made in Italy”.
Non meno vincente è il glocalismo virtuoso, ben tradotto dalle imprese italiane presso le quali il radicamento territoriale convive nell’interazione con reti globali. È l’impresa capace di aprirsi senza smarrirsi o isolarsi, che moltiplica opportunità e non ne sottrae, anche grazie alla capacità di mantenersi centrata sulla relazione di reciprocità e di portare una “sua” misura delle cose, parametrata sull’umano (impresa neghentropica). Una tensione che si ritrova fortemente nell’intervista a Loccioni o a Dallara, con la loro capacità di restare profondamente locali e non di meno globali. O nell’esperienza della Fondazione di Padernello, catalizzatrice di processi di rigenerazione territoriale di natura non localistica.
Infine, a fare la differenza sarà la resilienza generativa, intesa come adattabilità dell’impresa senza snaturamento identitario. Ovvero l’abilità di farsi promotori del cambiamento dentro una continuità di intenti. Anche a questo proposito le interviste, rimandano ad una forte coerenza biografica che fa da bussola in tempi incerti, ma anche diventa vantaggio distintivo e dunque competitivo.
Una competenza che diventa la forza di Edison, di ATM oggi anche nell’attraction e nella retention, o di Riso Gallo e di Andriani, nello sviluppo di nuovi prodotti frutto di una nuova agricoltura sostenibile.
Questi caratteri non sono folklore da museo, ma asset competitivi da reimmaginare. La vera questione dell’impresa italiana non è la dimensione – piccola o grande – ma l’incapacità di tradurre oggi questi valori in modelli organizzativi scalabili e in ecosistemi qualificati, senza perdere la sua natura originaria.
La doppia transizione digitale e generazionale costituisce per il nostro Paese un giro di boa particolarmente impegnativo, anche alla luce dei ritardi elencati.
Un passaggio da gestire con una duplice attenzione: su un fronte, integrando il digitale come abilitatore, piuttosto che come sostituto numerico dell’umano; sull’altro, investire nel ricambio generazionale preservando, riattualizzandola, la memoria d’impresa.
Questa metamorfosi richiede un nuovo alfabeto gestionale che coniughi:
- tecnologia abilitante (AI, IoT) con **saperi incarnati** dalle persone, dalle imprese, dai territori;
- processi agili con relazioni di fiducia
- open Innovation con autenticità dei prodotti.
Il compito storico è chiaro: evitare la deriva della barca Italia tra due estremi – la dedifferenziazione omologante e l’isolamento provincialista e involutivo/protettivo, ma anche tirare dritto, e mancare quel giro di boa che consentirebbe al Paese di restare in gara.
Fondamentale, in questa transizione, sarà la capacità di affrontare alcune questioni di fondo che appaiono in questo momento storico di assoluta necessità:
- un nuovo patto formazione-impresa per coltivare competenze ibride (tecnico-umanistiche)
- ecosistemi regionali come laboratori di sperimentazione glocal
- finanza paziente che premi l’originalità sulla standardizzazione.
In questa fase storica così critica, l’Italia può scrivere un capitolo inedito: dimostrare che produrre valore economico non è antitetico a creare bellezza e che efficienza numerica e human touch possono coesistere. Non si tratta di tornare al passato, ma di reincarnare lo spirito pionieristico delle origini in forme contemporanee.
Il futuro chiede alle imprese italiane di diventare ambasciatrici di un capitalismo umano-centrico, dove il profitto sia misura non solo di efficienza economica, ma di capacità di elevare comunità e paesaggi. Questa non è utopia: è l’unico realismo possibile per un Paese che vuole sfuggire al declino senza tradire sé stesso.
Al di là della dicotomia piccolo/grande
Negli anni Sessanta e Settanta, il Censis di Giuseppe De Rita contribuì a interpretare l’evoluzione di un Paese in pieno boom economico che imboccò una strada inattesa: quella del decentramento produttivo e della diffusione delle PMI. Fu la spinta imprenditoriale dal basso, infatti, a diventare il motore di una crescita economica tumultuosa, ma anche eterodossa rispetto alle principali teorie economiche del tempo.
Il grande merito dell’analisi del Censis fu quello di cogliere la dinamica profonda di una società che entrava con entusiasmo e determinazione nella sua stagione matura, mostrando una straordinaria vitalità ma anche una propria originalità e genialità.
L’Italia, infatti, è l’unico Paese in cui lo sviluppo economico del secondo Dopoguerra non si è accompagnato a una semplice crescita delle imprese esistenti, ma ha portato a un aumento significativo del loro numero.
L’interpretazione offerta dal Censis è stata però spesso contestata da chi sostiene che il problema dell’Italia è dato proprio dall’eccesso di piccole e medie imprese, considerate un vincolo alla modernizzazione del Paese. Secondo questa prospettiva, la soluzione sarebbe favorire un processo di aggregazione per creare imprese più grandi, capaci di superare i limiti di una struttura produttiva troppo frammentata.
In questo senso, il Rapporto fornisce alcuni elementi di valutazione che possono aiutare la riflessione ad andare oltre questa sterile contrapposizione, ormai superata anche dall’accresciuto fenomeno esemplare delle cosiddette “multinazionali tascabili”: imprese piccole e medie dinamiche che hanno mostrato una capacità competitiva basata non sui costi, ma sulla qualità della produzione e su un decentramento territoriale virtuoso.
Nel confronto con il panorama Europeo, l’idea che l’Italia sia un Paese fondato esclusivamente su piccole imprese appare solo parzialmente vera.
Intanto, questa caratteristica non sembra essere un’esclusiva italiana.
Osservando i dati continentali, fatta eccezione per Paesi con situazioni particolari come Lussemburgo, Svizzera, Irlanda e Olanda, il quadro dimensionale delle imprese italiane non è troppo diverso da quello di economie comparabili per popolazione e sviluppo.
Ad esempio, analizzando il numero di imprese per classi di addetti, emerge che il 94,6% delle imprese italiane sono microimprese con meno di 10 dipendenti, un valore in linea con la media europea (94,2%) e con Paesi come la Francia (96,1%) e la Spagna (94,8%). Solo la Germania presenta una percentuale significativamente inferiore (84%) e una distribuzione più bilanciata tra le varie dimensioni aziendali.
Anche il numero medio di addetti per impresa è in Italia simile a quello della Francia (4) e vicino a quello della Spagna (5) che è pari alla media europea. In questo caso, la distanza rimane significativa con la Germania, dove il valore sale a 12.
L’Italia si distingue per il numero totale di imprese. Rispetto a questo indicatore, il nostro Paese si colloca al secondo posto in Europa (4,5 mil), dopo la Francia (5 mil), e prima di Spagna (3,5 mil) e (piuttosto distaccata) la Germania (3,2 mil). Allo stesso tempo, l’Italia è prima per numero di imprese nei settori manifatturiero e commerciale.
Per trovare la specificità italiana, occorre però guardare in un’altra direzione.
Se si considera il fatturato netto, l’Italia si colloca al terzo posto (4,2 milioni di euro), dopo la Germania (marcatamente al vertice del ranking con 10,4 mil) e la Francia (5,6 mil), mentre fa meglio della Spagna (3,00).
Altro interessante indicatore è la distribuzione del fatturato netto per classe dimensionale. Dai dati emerge che in Italia le grandi imprese (oltre 250 addetti), pari allo 0,1% del totale delle imprese, generano solo il 38% del fatturato netto. In Francia, nonostante una percentuale simile di grandi imprese (0,1%) questo segmento arriva al 60%; mentre in Spagna – altra realtà non distante dalla nostra – tale valore è del 46%. In Germania, dove la quota di grandi imprese è più alta (0,4%), queste ultime generano il 63% del fatturato.
Per quanto riguarda il valore aggiunto, l’Italia è terza in Europa con 1,1 milioni di euro, dopo la Germania (2,9 milioni) e la Francia (1,5 milioni).
Più che la sola dimensione delle imprese, il modello italiano sembra dunque essere caratterizzato dai seguenti elementi chiave:
- maggiore contributo delle microimprese. In Italia, il contributo delle imprese sotto i 10 addetti (94,5% del totale) concorre per un 23% al fatturato netto totale, contro un 16% della medesima fascia dimensionale francese (pari a 96,1%) (tabella 3.2). Allargando la prospettiva e classi dimensionali, in Italia, le imprese con meno di 50 dipendenti contribuiscono per oltre il 40% al fatturato netto, contro il 28% della Francia, il 37% della Spagna, e il 23% della Germania. Guardando al fatturato netto per addetto, l’Italia supera Francia e Germania nelle classi 10-19, 20-49 dipendenti. Anche il valore aggiunto per classe di addetti segnala il 26% delle imprese italiane, contro un 16% di quelle francesi. (tabella 5.1). Nuovamente, in sintesi, il valore aggiunto apportato dalle imprese sotto i 50 dipendenti è pari al 45% in Italia e al 32% in Francia e Germania;
- forte presenza di medie imprese industriali. Guardando al fatturato netto per addetto, l’Italia supera Francia e Germania anche nella classe 50-249 dipendenti. Come mostra la letteratura economica, lo sviluppo delle medie imprese italiane – che garantiscono gran parte della capacità di export del nostro Paese – è in larga parte il risultato dell’evoluzione dei distretti industriali. Si tratta di un segmento di grande rilevanza economica e strategica che ha dimostrato, in presenza di talune condizioni, di sapersi evolvere ulteriormente, come conferma la “metamorfosi del modello emiliano”. I principali elementi che connotano questo particolare sviluppo sono: l’irrobustimento delle dimensioni delle imprese; la spiccata apertura internazionale; il convinto investimento nel fattore umano e in conoscenza; la capacità di infrastrutturare il contesto con reti fiduciarie e collaborative, oltre che con buone relazioni territoriali; il potenziamento delle specializzazioni di artigiania industriale e tecnologiche; la scelta chiara verso il miglioramento continuo della qualità di prodotti e servizi (innovazione) versus quantità (volumi); un dialogo convergente e fattivo tra sfera privata e sfera pubblica. In questo “modello” la vocazione imprenditiva e la ricerca della coesione sociale sono diffuse, la media impresa emergente è in grado di catalizzare e fare da traino a un sistema più ampio di filiera;
- scarsa presenza di grandi imprese. Storicamente, in Italia le imprese di grandi dimensioni sono state di proprietà statale ed attive in settori strategici come chimica, siderurgia ed energia, dove era necessaria una forte concentrazione di capitali per investimenti infrastrutturali. Nonostante l’ondata di privatizzazione degli anni Novanta, questo modello si conferma ancora oggi come tipico del nostro Paese. Di fatto, la globalizzazione ha colpito più le grandi imprese private italiane che le PMI. La ragione di questo risultato sta nel fatto che molte grandi imprese hanno puntato più su risultato finanziario che su quello industriale, con una conseguente riduzione della qualità e quantità del capitale investito. Il risultato è che, dal 1991 al 2016, il fatturato delle grandi imprese pubbliche italiane è passato da 75 a 150 miliardi di euro, mentre quello delle grandi imprese private è sceso da 55 a 29 miliardi. Questo calo è dovuto anche alla delocalizzazione: alcune aziende hanno scelto di trasferirsi all’estero, attratte da incentivi economici e fiscali, mentre altre sono state acquisite da gruppi stranieri. A parte le imprese private italiane, anche le estere segnalano delle difficoltà: l’investimento in Italia viene sospeso spesso a causa dell’assenza di un milieu favorevole giurisprudenziale e burocratico.
Il tessuto imprenditoriale italiano costituisce dunque un ecosistema articolato, caratterizzato da varietà dimensionale (dove convivono micro, piccole, medie/grandi imprese); pluralità settoriale (manifatturiero, servizi, agroalimentare); radicamento territoriale (sviluppo distrettuale, realtà urbane vs. periferiche). Questa particolare configurazione ha indiscutibili punti di forza, ma al tempo stesso vede diversi punti di fragilità strutturale, alcuni di questi già ben conosciuti in quanto derivanti dalla elevata frammentazione, dal passaggio di testimone dall’industria ai servizi – sebbene il sostrato manifatturiero resista e sia ancora solido –, dalla scarsa propensione a investire soprattutto da parte delle imprese piccole e micro. Un’incertezza che rimanda alla morfologia della struttura produttiva, ovvero se le imprese di questa fascia continueranno a esprimere soggetti imprenditoriali capaci di irrobustirsi ulteriormente. Con tutto le preoccupazioni che è legittimo avere tenendo conto delle forti tensioni geopolitiche e dell’instabilità del quadro macroeconomico globale.
Oggi, in particolare, tra le questioni con cui si trova a fare i conti ci sono:
– bassa produttività. In termini di produttività del lavoro corretta per i salari, l’Italia è al di sotto della media UE (149,4% contro 152,6% EU). Le conseguenze della bassa produttività sono importanti per la capacità del Paese di crescere e mantenere il livello di vita ottenuto nei decenni passati;
– bassi salari. Questo dato ha una triplice spiegazione. In primo luogo, il forte carico fiscale che pesa sul lavoro (parliamo di oneri sociali a carico del datore di lavoro che in Italia raggiungono il 27,6% delle retribuzioni, mentre la media EU è pari al 21,8%; in Francia sono i 28,3% mentre in Germania sono al 19,4%) che comprime le disponibilità economiche per sostenere gli stipendi. In secondo luogo, la tendenza a una redistribuzione delle risorse dal lavoro al capitale che si registra in Italia come in altri Paesi. Infine, la sopramenzionata bassa produttività che da un lato, comporta l’impossibilità di distribuire ricchezze e dall’altro persiste proprio in ragione dei bassi salari che costituiscono un’alternativa all’investimento in nuove tecnologie e nuovi modelli organizzativi;
– vulnerabilità di un modello centrato sulle medie imprese altamente competitive. La forte instabilità geopolitica rischia di mettere a repentaglio i risultati ottenuti. Tanto più che la virtuosità della parte esportatrice del modello economico italiano non è allineata con il forte indebitamento pubblico e la più generale scarsa produttività del Paese. È come se ci fossero due Italie che hanno ben poco a che fare l’una con l’altra, dove la prima in larga parte sostiene la seconda;
– limitata stabilità finanziaria. Da uno sguardo complessivo, la recente riduzione dei tassi di interesse fornisce un impulso positivo all’economia. Tuttavia, la redditività delle imprese ha mostrato segni di peggioramento, e stabile è risultato il credito erogato rispetto allo scorso anno (+0,9%) con una lieve crescita in termini di importi (+2,4%) nonostante gli aumentati costi di finanziamento. La capacità delle imprese di rimborsare i debiti è restata mediamente buona, e il tasso di deterioramento dei prestiti bancari si è confermato contenuto6 Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2 – 2024; mentre il tasso di default medio delle società di capitali è stimato a fine 2024 in leggero incremento sull’anno precedente (+2,9%)7 CRIF, Osservatorio sulle imprese, febbraio 2025. Questo scenario evidenzia una fragilità strutturale, che ostacola gli investimenti e le strategie di lungo periodo. Sul sistema finanziario italiano si è scritto molto, in particolare a proposito di un modello “banco-centrico”. Anche in relazione ai processi di verticalizzazione in atto, il tema dell’accesso alle risorse finanziarie merita di essere considerato con attenzione, in rapporto alle caratteristiche intrinseche dell’imprendività Italiana. Anche i dati relativi alle imprese sociali del nostro Paese rilevano un quadro finanziario fragile; il 68% delle imprese sociale dichiara di avere un orizzonte di sostenibilità finanziaria di soli 12 mesi; il 16% circa una sostenibilità inferiore ai 3 mesi; solo il 7% circa afferma di avere una prospettiva superiore ai 24 mesi.
In realtà, la polarità piccolo/grande racconta molto di più di quello che si è soliti pensare. Essa nasconde in sé la tensione di fondo tra standardizzazione e scalabilità da un lato, e varianza e innovazione, dall’altro; o tra globalizzazione da un lato, e radicamento locale dall’altro.
Il modello italiano si caratterizza per la forte presenza di una élite con matrice industrialista impegnata a enfatizzare le condizioni peculiari delle competenze locali; che anima un’imprenditorialità vigorosa e un’economia intermedia operante secondo logiche di filiera, lascito di una lunga storia di creative produzioni artigianali.
La gestione di questa tensione non è mai stata facile per il nostro Paese che ha dimostrato di non essere a misura delle grandi imprese. E non lo è tutt’oggi.
Tale tensione ruota attorno a tre elementi chiave, peraltro scarsamente compresi e persino conosciuti nel dibattito sull’impresa Italia a:
- tecnodiversità, ovvero la capacità dell’imprenditoria italiana di integrare diverse tecnologie e molteplici approcci innovativi;
- neghentropia, cioè la capacità di contrastare i processi di disordine e decadimento attraverso la generazione di valore sostenibile nel tempo, rendendo riflessiva la produzione e l’uso delle conoscenze da cui possono derivare inediti stati di ordine;
- ecosistemicitá, come creazione di un contesto favorevole in grado di supportare la crescita e l’innovazione delle imprese, indipendentemente dalla loro dimensione.
É riconoscendo e valorizzando questi tre fattori e facendoli interagire strategicamente tra loro che è possibile superare il rischio di rimanere bloccati in una contrapposizione che non porta di nessuna parte. La sfida è aprire nuovi immaginari sull’impresa e disegnare scenari di sviluppo per una imprenditività che paga la fatica di sviluppare una visione binoculare – universale e insieme particolare – come è del resto l’anima più profonda del Paese.
Negli anni Sessanta e Settanta, il Censis di Giuseppe De Rita contribuì a interpretare l’evoluzione di un Paese in pieno boom economico che imboccò una strada inattesa: quella del decentramento produttivo e della diffusione delle PMI. Fu la spinta imprenditoriale dal basso, infatti, a diventare il motore di una crescita economica tumultuosa, ma anche eterodossa rispetto alle principali teorie economiche del tempo.
Il grande merito dell’analisi del Censis fu quello di cogliere la dinamica profonda di una società che entrava con entusiasmo e determinazione nella sua stagione matura, mostrando una straordinaria vitalità ma anche una propria originalità e genialità.
L’Italia, infatti, è l’unico Paese in cui lo sviluppo economico del secondo Dopoguerra non si è accompagnato a una semplice crescita delle imprese esistenti, ma ha portato a un aumento significativo del loro numero.
L’interpretazione offerta dal Censis è stata però spesso contestata da chi sostiene che il problema dell’Italia è dato proprio dall’eccesso di piccole e medie imprese, considerate un vincolo alla modernizzazione del Paese. Secondo questa prospettiva, la soluzione sarebbe favorire un processo di aggregazione per creare imprese più grandi, capaci di superare i limiti di una struttura produttiva troppo frammentata.
In questo senso, il Rapporto fornisce alcuni elementi di valutazione che possono aiutare la riflessione ad andare oltre questa sterile contrapposizione, ormai superata anche dall’accresciuto fenomeno esemplare delle cosiddette “multinazionali tascabili”: imprese piccole e medie dinamiche che hanno mostrato una capacità competitiva basata non sui costi, ma sulla qualità della produzione e su un decentramento territoriale virtuoso.
Nel confronto con il panorama Europeo, l’idea che l’Italia sia un Paese fondato esclusivamente su piccole imprese appare solo parzialmente vera.
Intanto, questa caratteristica non sembra essere un’esclusiva italiana.
Osservando i dati continentali, fatta eccezione per Paesi con situazioni particolari come Lussemburgo, Svizzera, Irlanda e Olanda, il quadro dimensionale delle imprese italiane non è troppo diverso da quello di economie comparabili per popolazione e sviluppo.
Ad esempio, analizzando il numero di imprese per classi di addetti, emerge che il 94,6% delle imprese italiane sono microimprese con meno di 10 dipendenti, un valore in linea con la media europea (94,2%) e con Paesi come la Francia (96,1%) e la Spagna (94,8%). Solo la Germania presenta una percentuale significativamente inferiore (84%) e una distribuzione più bilanciata tra le varie dimensioni aziendali.
Anche il numero medio di addetti per impresa è in Italia simile a quello della Francia (4) e vicino a quello della Spagna (5) che è pari alla media europea. In questo caso, la distanza rimane significativa con la Germania, dove il valore sale a 12.
L’Italia si distingue per il numero totale di imprese. Rispetto a questo indicatore, il nostro Paese si colloca al secondo posto in Europa (4,5 mil), dopo la Francia (5 mil), e prima di Spagna (3,5 mil) e (piuttosto distaccata) la Germania (3,2 mil). Allo stesso tempo, l’Italia è prima per numero di imprese nei settori manifatturiero e commerciale.
Per trovare la specificità italiana, occorre però guardare in un’altra direzione.
Se si considera il fatturato netto, l’Italia si colloca al terzo posto (4,2 milioni di euro), dopo la Germania (marcatamente al vertice del ranking con 10,4 mil) e la Francia (5,6 mil), mentre fa meglio della Spagna (3,00).
Altro interessante indicatore è la distribuzione del fatturato netto per classe dimensionale. Dai dati emerge che in Italia le grandi imprese (oltre 250 addetti), pari allo 0,1% del totale delle imprese, generano solo il 38% del fatturato netto. In Francia, nonostante una percentuale simile di grandi imprese (0,1%) questo segmento arriva al 60%; mentre in Spagna – altra realtà non distante dalla nostra – tale valore è del 46%. In Germania, dove la quota di grandi imprese è più alta (0,4%), queste ultime generano il 63% del fatturato.
Per quanto riguarda il valore aggiunto, l’Italia è terza in Europa con 1,1 milioni di euro, dopo la Germania (2,9 milioni) e la Francia (1,5 milioni).
Più che la sola dimensione delle imprese, il modello italiano sembra dunque essere caratterizzato dai seguenti elementi chiave:
- maggiore contributo delle microimprese. In Italia, il contributo delle imprese sotto i 10 addetti (94,5% del totale) concorre per un 23% al fatturato netto totale, contro un 16% della medesima fascia dimensionale francese (pari a 96,1%) (tabella 3.2). Allargando la prospettiva e classi dimensionali, in Italia, le imprese con meno di 50 dipendenti contribuiscono per oltre il 40% al fatturato netto, contro il 28% della Francia, il 37% della Spagna, e il 23% della Germania. Guardando al fatturato netto per addetto, l’Italia supera Francia e Germania nelle classi 10-19, 20-49 dipendenti. Anche il valore aggiunto per classe di addetti segnala il 26% delle imprese italiane, contro un 16% di quelle francesi. (tabella 5.1). Nuovamente, in sintesi, il valore aggiunto apportato dalle imprese sotto i 50 dipendenti è pari al 45% in Italia e al 32% in Francia e Germania;
- forte presenza di medie imprese industriali. Guardando al fatturato netto per addetto, l’Italia supera Francia e Germania anche nella classe 50-249 dipendenti. Come mostra la letteratura economica, lo sviluppo delle medie imprese italiane – che garantiscono gran parte della capacità di export del nostro Paese – è in larga parte il risultato dell’evoluzione dei distretti industriali. Si tratta di un segmento di grande rilevanza economica e strategica che ha dimostrato, in presenza di talune condizioni, di sapersi evolvere ulteriormente, come conferma la “metamorfosi del modello emiliano”. I principali elementi che connotano questo particolare sviluppo sono: l’irrobustimento delle dimensioni delle imprese; la spiccata apertura internazionale; il convinto investimento nel fattore umano e in conoscenza; la capacità di infrastrutturare il contesto con reti fiduciarie e collaborative, oltre che con buone relazioni territoriali; il potenziamento delle specializzazioni di artigiania industriale e tecnologiche; la scelta chiara verso il miglioramento continuo della qualità di prodotti e servizi (innovazione) versus quantità (volumi); un dialogo convergente e fattivo tra sfera privata e sfera pubblica. In questo “modello” la vocazione imprenditiva e la ricerca della coesione sociale sono diffuse, la media impresa emergente è in grado di catalizzare e fare da traino a un sistema più ampio di filiera;
- scarsa presenza di grandi imprese. Storicamente, in Italia le imprese di grandi dimensioni sono state di proprietà statale ed attive in settori strategici come chimica, siderurgia ed energia, dove era necessaria una forte concentrazione di capitali per investimenti infrastrutturali. Nonostante l’ondata di privatizzazione degli anni Novanta, questo modello si conferma ancora oggi come tipico del nostro Paese. Di fatto, la globalizzazione ha colpito più le grandi imprese private italiane che le PMI. La ragione di questo risultato sta nel fatto che molte grandi imprese hanno puntato più su risultato finanziario che su quello industriale, con una conseguente riduzione della qualità e quantità del capitale investito. Il risultato è che, dal 1991 al 2016, il fatturato delle grandi imprese pubbliche italiane è passato da 75 a 150 miliardi di euro, mentre quello delle grandi imprese private è sceso da 55 a 29 miliardi. Questo calo è dovuto anche alla delocalizzazione: alcune aziende hanno scelto di trasferirsi all’estero, attratte da incentivi economici e fiscali, mentre altre sono state acquisite da gruppi stranieri. A parte le imprese private italiane, anche le estere segnalano delle difficoltà: l’investimento in Italia viene sospeso spesso a causa dell’assenza di un milieu favorevole giurisprudenziale e burocratico.
Il tessuto imprenditoriale italiano costituisce dunque un ecosistema articolato, caratterizzato da varietà dimensionale (dove convivono micro, piccole, medie/grandi imprese); pluralità settoriale (manifatturiero, servizi, agroalimentare); radicamento territoriale (sviluppo distrettuale, realtà urbane vs. periferiche). Questa particolare configurazione ha indiscutibili punti di forza, ma al tempo stesso vede diversi punti di fragilità strutturale, alcuni di questi già ben conosciuti in quanto derivanti dalla elevata frammentazione, dal passaggio di testimone dall’industria ai servizi – sebbene il sostrato manifatturiero resista e sia ancora solido –, dalla scarsa propensione a investire soprattutto da parte delle imprese piccole e micro. Un’incertezza che rimanda alla morfologia della struttura produttiva, ovvero se le imprese di questa fascia continueranno a esprimere soggetti imprenditoriali capaci di irrobustirsi ulteriormente. Con tutto le preoccupazioni che è legittimo avere tenendo conto delle forti tensioni geopolitiche e dell’instabilità del quadro macroeconomico globale.
Oggi, in particolare, tra le questioni con cui si trova a fare i conti ci sono:
– bassa produttività. In termini di produttività del lavoro corretta per i salari, l’Italia è al di sotto della media UE (149,4% contro 152,6% EU). Le conseguenze della bassa produttività sono importanti per la capacità del Paese di crescere e mantenere il livello di vita ottenuto nei decenni passati;
– bassi salari. Questo dato ha una triplice spiegazione. In primo luogo, il forte carico fiscale che pesa sul lavoro (parliamo di oneri sociali a carico del datore di lavoro che in Italia raggiungono il 27,6% delle retribuzioni, mentre la media EU è pari al 21,8%; in Francia sono i 28,3% mentre in Germania sono al 19,4%) che comprime le disponibilità economiche per sostenere gli stipendi. In secondo luogo, la tendenza a una redistribuzione delle risorse dal lavoro al capitale che si registra in Italia come in altri Paesi. Infine, la sopramenzionata bassa produttività che da un lato, comporta l’impossibilità di distribuire ricchezze e dall’altro persiste proprio in ragione dei bassi salari che costituiscono un’alternativa all’investimento in nuove tecnologie e nuovi modelli organizzativi;
– vulnerabilità di un modello centrato sulle medie imprese altamente competitive. La forte instabilità geopolitica rischia di mettere a repentaglio i risultati ottenuti. Tanto più che la virtuosità della parte esportatrice del modello economico italiano non è allineata con il forte indebitamento pubblico e la più generale scarsa produttività del Paese. È come se ci fossero due Italie che hanno ben poco a che fare l’una con l’altra, dove la prima in larga parte sostiene la seconda;
– limitata stabilità finanziaria. Da uno sguardo complessivo, la recente riduzione dei tassi di interesse fornisce un impulso positivo all’economia. Tuttavia, la redditività delle imprese ha mostrato segni di peggioramento, e stabile è risultato il credito erogato rispetto allo scorso anno (+0,9%) con una lieve crescita in termini di importi (+2,4%) nonostante gli aumentati costi di finanziamento. La capacità delle imprese di rimborsare i debiti è restata mediamente buona, e il tasso di deterioramento dei prestiti bancari si è confermato contenuto8 Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2 – 2024; mentre il tasso di default medio delle società di capitali è stimato a fine 2024 in leggero incremento sull’anno precedente (+2,9%)9 CRIF, Osservatorio sulle imprese, febbraio 2025. Questo scenario evidenzia una fragilità strutturale, che ostacola gli investimenti e le strategie di lungo periodo. Sul sistema finanziario italiano si è scritto molto, in particolare a proposito di un modello “banco-centrico”. Anche in relazione ai processi di verticalizzazione in atto, il tema dell’accesso alle risorse finanziarie merita di essere considerato con attenzione, in rapporto alle caratteristiche intrinseche dell’imprendività Italiana. Anche i dati relativi alle imprese sociali del nostro Paese rilevano un quadro finanziario fragile; il 68% delle imprese sociale dichiara di avere un orizzonte di sostenibilità finanziaria di soli 12 mesi; il 16% circa una sostenibilità inferiore ai 3 mesi; solo il 7% circa afferma di avere una prospettiva superiore ai 24 mesi.
In realtà, la polarità piccolo/grande racconta molto di più di quello che si è soliti pensare. Essa nasconde in sé la tensione di fondo tra standardizzazione e scalabilità da un lato, e varianza e innovazione, dall’altro; o tra globalizzazione da un lato, e radicamento locale dall’altro.
Il modello italiano si caratterizza per la forte presenza di una élite con matrice industrialista impegnata a enfatizzare le condizioni peculiari delle competenze locali; che anima un’imprenditorialità vigorosa e un’economia intermedia operante secondo logiche di filiera, lascito di una lunga storia di creative produzioni artigianali.
La gestione di questa tensione non è mai stata facile per il nostro Paese che ha dimostrato di non essere a misura delle grandi imprese. E non lo è tutt’oggi.
Tale tensione ruota attorno a tre elementi chiave, peraltro scarsamente compresi e persino conosciuti nel dibattito sull’impresa Italia a:
- tecnodiversità, ovvero la capacità dell’imprenditoria italiana di integrare diverse tecnologie e molteplici approcci innovativi;
- neghentropia, cioè la capacità di contrastare i processi di disordine e decadimento attraverso la generazione di valore sostenibile nel tempo, rendendo riflessiva la produzione e l’uso delle conoscenze da cui possono derivare inediti stati di ordine;
- ecosistemicitá, come creazione di un contesto favorevole in grado di supportare la crescita e l’innovazione delle imprese, indipendentemente dalla loro dimensione.
É riconoscendo e valorizzando questi tre fattori e facendoli interagire strategicamente tra loro che è possibile superare il rischio di rimanere bloccati in una contrapposizione che non porta di nessuna parte. La sfida è aprire nuovi immaginari sull’impresa e disegnare scenari di sviluppo per una imprenditività che paga la fatica di sviluppare una visione binoculare – universale e insieme particolare – come è del resto l’anima più profonda del Paese.
Tecnodiversità: l’impresa italiana davanti alla sfida digitale e organizzativa
La digitalizzazione rappresenta il nuovo ambiente tecnologico in cui si svolge l’attività imprenditoriale. Comprendere il posizionamento dell’Italia nella transizione digitale è dunque cruciale per valutare le sfide e le opportunità future.
Rispetto a questa transizione, l’Italia si caratterizza per la presenza di luci e ombre.
Sul fronte della digital intensity, ovvero la diffusione di tecnologie digitali di base tra le aziende, l’Italia si colloca sopra la media UE, subito dietro la Germania e davanti alla Francia.
Tuttavia, il quadro cambia radicalmente se si considera l’adozione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale (AI). In questo ambito, i dati raccontano di un’Italia è molto distante dai Paesi leader del ranking, come Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi, ma anche dalla Germania, che, pur essendo più vicina al nostro posizionamento, registra livelli di adozione significativamente superiori.
Ancora più fosca è la prospettiva a cinque anni: oltre il 50% delle aziende italiane dichiara che non utilizzerà l’AI, o che il suo impatto sulle attività aziendali sarà irrilevante. Inoltre, un ulteriore 9% non ha espresso alcuna previsione, segno di una mancanza di visione strategica in questo ambito. Ad oggi, l’impiego delle tecnologie emergenti rimane particolarmente basso nel nostro Paese, evidenziando un certo ritardo nella capacità di analisi avanzata delle informazioni.
Anche sul fronte dell’e-commerce, l’Italia si colloca al di sotto della media UE per numero di aziende che lo utilizzano. Tuttavia, in termini di fatturato derivante dal commercio elettronico, il Paese si avvicina alla media europea. Questo suggerisce che un’adozione più ampia delle transazioni via Internet potrebbe portare a un incremento significativo dell’attività commerciale. Al momento, però, il numero di imprese italiane in cui l’e-commerce genera almeno l’1% del fatturato resta molto basso.
Infine, per quanto riguarda l’export di prodotti ad alto contenuto tecnologico, l’Italia registra un valore di 83,25 secondo l’indicatore EIS, costruito ponendo la media UE del 2016 pari a 100.
Questo dato indica una performance inferiore rispetto alla media europea attuale (99,33) e a economie come la Germania (112,03) e la Francia (86,75), segnalando una minore competitività del Paese nel settore high-tech rispetto ai principali partner europei.
Questi dati mostrano un’Italia con buone basi digitali, ma in ritardo sull’adozione di tecnologie avanzate e sull’evoluzione del commercio digitale. Dato che non deve stupire tenuto conto che per quanto riguarda gli investimenti nelle PMI l’Italia si trova a metà classifica, dietro a Francia e Germania (top performer: Finlandia, Svizzera).
Ma aldilà del dato puramente quantitativo, la questione digitale va considerata dal punto di vista qualitativo. Per l’Italia, questa transizione costituisce, infatti, una sfida particolarmente impegnativa, poiché le nuove tecnologie digitali posseggono un forte potere di standardizzazione e burocratizzazione. Da questo punto di vista, non si riduce alla capacità delle imprese italiane di adottare le nuove tecnologie digitali (condizione necessaria) ma implica la capacità delle stesse imprese di utilizzare tali tecnologie per rafforzare quelle specificità che sono allo base anche dell loro successo.
Il pluralismo digitale è una risorsa essenziale, ma rappresenta anche un potenziale rischio per un modello italiano basato sulla tecnodiversità. Con questo termine si intende la capacità non solo di adottare o conservare una tecnologia, ma di personalizzarla e manipolarla in base a quella “cosmologia” – da intendersi come un insieme di fattori generativi come lingua, cultura, visione del mondo, tradizione, sensibilità artistica, professionalità e modelli organizzativi – che, guidando il divenire, conferisce un vantaggio competitivo.
La tensione del rapporto piccole e medie e grandi imprese sopracitata sta tutta qui. L’Italia, infatti, non è semplicemente una terzista di altri Paesi. Piuttosto, il sistema imprenditoriale italiano si è storicamente distinto – e continua a distinguersi – per la sua capacità di gestire in maniera originale ed efficace la disponibilità tecnologica di ogni tempo.
Ciò molto concretamente significa che lo specifico del mondo delle piccole e medie imprese italiane deriva dalla sua capacità di una artigiania che gli altri paesi non riescono a raggiungere, ovvero di quella attitudine manipolativa della tecnologia che, creando contesti lavorativi peculiari, riesce a generare un vantaggio competitivo.
Questa tematica è particolarmente rilevante in un momento in cui la digitalizzazione, da un lato, introduce un ulteriore livello di standardizzazione, ma dall’altro può aprire nuove possibilità di variazione e innovazione.
Se proviamo a trarre un’indicazione da quanto è accaduto con precedenti ambienti tecnologici, l’Italia ha sì un problema di raggiungere una familiarità con la nuova tecnologia e la disponibilità di infrastrutture e professionalità adeguate, ma anche la possibilità di riuscire a non sottomettersi a rigidità logiche che tenderebbero a distruggere il patrimonio della specificità italiana.
La chiave di volta della tecnodiversità ha prima di tutto a che fare con i modelli organizzativi, oltre che con quelli formativi. Per questa ragione è utile guardare alla transizione digitale considerando quanto sta accadendo nel mercato del lavoro, sia dal lato della domanda che dell’offerta.
Accanto al noto mismatch delle competenze – il divario tra le competenze richieste e quelle effettivamente disponibili sul mercato – si è andato aggiungendo negli ultimi anni un crescente skill shortage, dovuto alla scarsità di persone disponibili a entrare nella forza lavoro. Le cause sono molteplici: il cambiamento demografico; le scelte delle nuove generazioni che vedono maggiori opportunità all’estero rispetto all’Italia; un sistema retributivo poco competitivo; la debole efficacia delle politiche di conciliazione.
I dati confermano le difficoltà nel reperire personale qualificato: ben il 69% delle imprese dichiara di incontrare molta o abbastanza difficoltà nella ricerca di figure professionali adeguate. Inoltre, i tempi di reclutamento non sono sempre rapidi. Le cause principali della difficoltà nel reperire personale, secondo le aziende italiane, sono la mancanza di conoscenze e competenze adeguate nei candidati (57%), ma anche la scarsità o perfino l’assenza di candidati disponibili (54%).
Questa situazione ha un impatto significativo sulle imprese. Tra le conseguenze principali vengono segnalate: sovraccarico di lavoro sul personale disponibile; aumento dei costi di produzione; mancate vendite o problemi di espansione commerciale.
Per fronteggiare questo problema, le aziende stanno adottando alcune strategie, tra le quali il miglioramento delle condizioni di lavoro – leva importante che contribuisce a rendere queste aziende più attrattive per la forza lavoro, specie quella qualificata –; l’investimento nell’upskilling e reskilling del personale; l’ampliamento dei canali di reclutamento (social media, piattaforme digitali, advertising); l’utilizzo di lavoratori temporanei o autonomi.
Tuttavia, il tasso di coinvolgimento dei lavoratori nelle attività imprenditoriali vede l’Italia in posizione intermedia. Eppure, un maggiore coinvolgimento potrebbe favorire una cultura dell’intrapresa, allargando gli spazi per l’iniziativa e l’innovazione. Su due aspetti chiave – rilevati dalle analisi sulle scelte delle imprese sociali – emergono chiari margini di miglioramento: il coinvolgimento dei beneficiari nelle decisioni aziendali (l’Italia è sotto la media ESEM, superato da Turchia, Lituania, Svezia, Estonia e Portogallo); e la partecipazione dello staff alle decisioni aziendali (anche qui l’Italia si colloca a metà classifica, lontana dai primi tre Paesi Svezia, Turchia, Estonia).
Migliorare questi aspetti potrebbe favorire una cultura più aperta alla partecipazione e all’innovazione, incentivando processi imprenditoriali più efficaci e dinamici10 F. Mosconi, Modello Emilia. Imprese innovative e spirito di comunità, Posteditori, 2023.
I dati11 Si ricorda che i dati raccolti datati 2023 si riferiscono al 2022. , dunque, non appaiono particolarmente confortanti per il nostro Paese sia per quanto riguarda l’ingresso nel mondo digitale, sia per quanto riguarda i modelli organizzativi. Gli elementi di confronto internazionale mostrano alcune debolezze del nostro Paese.
Almeno in parte, la ricerca qualitativa contribuisce a correggere queste indicazioni negative. Le imprese studiate si rivelano, infatti, assai capaci di rigenerare la tecnodiversità base del modello socioeconomico italiano a partire da un convinto investimento nelle persone, nei loro talenti e nelle loro competenze, sia direttamente – ad esempio sul fronte della formazione – sia indirettamente – agevolando quelle condizioni di base che consentono un coinvolgimento reciproco tra persone e imprese, più soddisfacente e di più lungo termine; così come gli interventi sul fronte della conciliazione tra vita professionale e familiare, sul tema salute o della casa raccontano.
Ciò ci dice che continua a esistere un gruppo anche relativamente nutrito (ma certamente ancora minoritario) di imprese capace di affrontare la transizione digitale senza perdere, anzi, rafforzando quella specificità che rende forte l’impresa Italia. Purtroppo, questo non riguarda l’intera popolazione imprenditoriale.
Il problema è quello di estendere a tutto il tessuto imprenditoriale queste attitudini, contrastando la tendenza (che ritorna sempre nel nostro sistema economico) a ripiegarsi, vuoi nella direzione di un progressivo sfruttamento delle risorse umane e tecniche con la riduzione degli investimenti e lo scarso investimento nei modelli organizzativi, vuoi nell’incapacità di ragionare in termini sistemici e di rete, adottando strategie competitive e/o di collaborazione con altri player nel lungo periodo. Un’altra polarizzazione tutta italiana che impedisce di coniugare spinta all’innovazione e “spirito di comunità” ingredienti che appaiono decisivi nell’immaginare lo sviluppo del Paese.
Un’ultima questione ha a che fare con il necessario processo di managerializzazione che sta interessando un numero crescente di imprese Italiane, anche in rapporto al ricambio generazionale di molte piccole e medie imprese. Ancora una volta, occorre andare al di là di una sterile contrapposizione tra la figura eroica dell’imprenditore e quella d’ordine del manager. Tale contrapposizione che si nutre di luoghi comuni ma anche di culture improprie costituisce un blocco da superare.
La chiave per andare oltre ha che fare con quanto emerge dai dati: il sistema delle imprese italiano ha bisogno di fare un salto nella sua qualità organizzativa, obiettivo che può essere raggiunto anche grazie al contributo di manager esperti. Ma ciò a condizione che la competenza manageriale non sia giocata nel senso di una normalizzazione del modello d’impresa italiano. Ma piuttosto come elemento in grado di superare i limiti legati all’eccessiva personalizzazione dell’esperienza imprenditoriale. Un passaggio particolarmente importante, tenendo conto del tema della transizione generazionale che interessa molte imprese del nostro Paese.
La digitalizzazione rappresenta il nuovo ambiente tecnologico in cui si svolge l’attività imprenditoriale. Comprendere il posizionamento dell’Italia nella transizione digitale è dunque cruciale per valutare le sfide e le opportunità future.
Rispetto a questa transizione, l’Italia si caratterizza per la presenza di luci e ombre.
Sul fronte della digital intensity, ovvero la diffusione di tecnologie digitali di base tra le aziende, l’Italia si colloca sopra la media UE, subito dietro la Germania e davanti alla Francia.
Tuttavia, il quadro cambia radicalmente se si considera l’adozione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale (AI). In questo ambito, i dati raccontano di un’Italia è molto distante dai Paesi leader del ranking, come Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi, ma anche dalla Germania, che, pur essendo più vicina al nostro posizionamento, registra livelli di adozione significativamente superiori.
Ancora più fosca è la prospettiva a cinque anni: oltre il 50% delle aziende italiane dichiara che non utilizzerà l’AI, o che il suo impatto sulle attività aziendali sarà irrilevante. Inoltre, un ulteriore 9% non ha espresso alcuna previsione, segno di una mancanza di visione strategica in questo ambito. Ad oggi, l’impiego delle tecnologie emergenti rimane particolarmente basso nel nostro Paese, evidenziando un certo ritardo nella capacità di analisi avanzata delle informazioni.
Anche sul fronte dell’e-commerce, l’Italia si colloca al di sotto della media UE per numero di aziende che lo utilizzano. Tuttavia, in termini di fatturato derivante dal commercio elettronico, il Paese si avvicina alla media europea. Questo suggerisce che un’adozione più ampia delle transazioni via Internet potrebbe portare a un incremento significativo dell’attività commerciale. Al momento, però, il numero di imprese italiane in cui l’e-commerce genera almeno l’1% del fatturato resta molto basso.
Infine, per quanto riguarda l’export di prodotti ad alto contenuto tecnologico, l’Italia registra un valore di 83,25 secondo l’indicatore EIS, costruito ponendo la media UE del 2016 pari a 100.
Questo dato indica una performance inferiore rispetto alla media europea attuale (99,33) e a economie come la Germania (112,03) e la Francia (86,75), segnalando una minore competitività del Paese nel settore high-tech rispetto ai principali partner europei.
Questi dati mostrano un’Italia con buone basi digitali, ma in ritardo sull’adozione di tecnologie avanzate e sull’evoluzione del commercio digitale. Dato che non deve stupire tenuto conto che per quanto riguarda gli investimenti nelle PMI l’Italia si trova a metà classifica, dietro a Francia e Germania (top performer: Finlandia, Svizzera).
Ma aldilà del dato puramente quantitativo, la questione digitale va considerata dal punto di vista qualitativo. Per l’Italia, questa transizione costituisce, infatti, una sfida particolarmente impegnativa, poiché le nuove tecnologie digitali posseggono un forte potere di standardizzazione e burocratizzazione. Da questo punto di vista, non si riduce alla capacità delle imprese italiane di adottare le nuove tecnologie digitali (condizione necessaria) ma implica la capacità delle stesse imprese di utilizzare tali tecnologie per rafforzare quelle specificità che sono allo base anche dell loro successo.
Il pluralismo digitale è una risorsa essenziale, ma rappresenta anche un potenziale rischio per un modello italiano basato sulla tecnodiversità. Con questo termine si intende la capacità non solo di adottare o conservare una tecnologia, ma di personalizzarla e manipolarla in base a quella “cosmologia” – da intendersi come un insieme di fattori generativi come lingua, cultura, visione del mondo, tradizione, sensibilità artistica, professionalità e modelli organizzativi – che, guidando il divenire, conferisce un vantaggio competitivo.
La tensione del rapporto piccole e medie e grandi imprese sopracitata sta tutta qui. L’Italia, infatti, non è semplicemente una terzista di altri Paesi. Piuttosto, il sistema imprenditoriale italiano si è storicamente distinto – e continua a distinguersi – per la sua capacità di gestire in maniera originale ed efficace la disponibilità tecnologica di ogni tempo.
Ciò molto concretamente significa che lo specifico del mondo delle piccole e medie imprese italiane deriva dalla sua capacità di una artigiania che gli altri paesi non riescono a raggiungere, ovvero di quella attitudine manipolativa della tecnologia che, creando contesti lavorativi peculiari, riesce a generare un vantaggio competitivo.
Questa tematica è particolarmente rilevante in un momento in cui la digitalizzazione, da un lato, introduce un ulteriore livello di standardizzazione, ma dall’altro può aprire nuove possibilità di variazione e innovazione.
Se proviamo a trarre un’indicazione da quanto è accaduto con precedenti ambienti tecnologici, l’Italia ha sì un problema di raggiungere una familiarità con la nuova tecnologia e la disponibilità di infrastrutture e professionalità adeguate, ma anche la possibilità di riuscire a non sottomettersi a rigidità logiche che tenderebbero a distruggere il patrimonio della specificità italiana.
La chiave di volta della tecnodiversità ha prima di tutto a che fare con i modelli organizzativi, oltre che con quelli formativi. Per questa ragione è utile guardare alla transizione digitale considerando quanto sta accadendo nel mercato del lavoro, sia dal lato della domanda che dell’offerta.
Accanto al noto mismatch delle competenze – il divario tra le competenze richieste e quelle effettivamente disponibili sul mercato – si è andato aggiungendo negli ultimi anni un crescente skill shortage, dovuto alla scarsità di persone disponibili a entrare nella forza lavoro. Le cause sono molteplici: il cambiamento demografico; le scelte delle nuove generazioni che vedono maggiori opportunità all’estero rispetto all’Italia; un sistema retributivo poco competitivo; la debole efficacia delle politiche di conciliazione.
I dati confermano le difficoltà nel reperire personale qualificato: ben il 69% delle imprese dichiara di incontrare molta o abbastanza difficoltà nella ricerca di figure professionali adeguate. Inoltre, i tempi di reclutamento non sono sempre rapidi. Le cause principali della difficoltà nel reperire personale, secondo le aziende italiane, sono la mancanza di conoscenze e competenze adeguate nei candidati (57%), ma anche la scarsità o perfino l’assenza di candidati disponibili (54%).
Questa situazione ha un impatto significativo sulle imprese. Tra le conseguenze principali vengono segnalate: sovraccarico di lavoro sul personale disponibile; aumento dei costi di produzione; mancate vendite o problemi di espansione commerciale.
Per fronteggiare questo problema, le aziende stanno adottando alcune strategie, tra le quali il miglioramento delle condizioni di lavoro – leva importante che contribuisce a rendere queste aziende più attrattive per la forza lavoro, specie quella qualificata –; l’investimento nell’upskilling e reskilling del personale; l’ampliamento dei canali di reclutamento (social media, piattaforme digitali, advertising); l’utilizzo di lavoratori temporanei o autonomi.
Tuttavia, il tasso di coinvolgimento dei lavoratori nelle attività imprenditoriali vede l’Italia in posizione intermedia. Eppure, un maggiore coinvolgimento potrebbe favorire una cultura dell’intrapresa, allargando gli spazi per l’iniziativa e l’innovazione. Su due aspetti chiave – rilevati dalle analisi sulle scelte delle imprese sociali – emergono chiari margini di miglioramento: il coinvolgimento dei beneficiari nelle decisioni aziendali (l’Italia è sotto la media ESEM, superato da Turchia, Lituania, Svezia, Estonia e Portogallo); e la partecipazione dello staff alle decisioni aziendali (anche qui l’Italia si colloca a metà classifica, lontana dai primi tre Paesi Svezia, Turchia, Estonia).
Migliorare questi aspetti potrebbe favorire una cultura più aperta alla partecipazione e all’innovazione, incentivando processi imprenditoriali più efficaci e dinamici12 F. Mosconi, Modello Emilia. Imprese innovative e spirito di comunità, Posteditori, 2023.
I dati13 Si ricorda che i dati raccolti datati 2023 si riferiscono al 2022. , dunque, non appaiono particolarmente confortanti per il nostro Paese sia per quanto riguarda l’ingresso nel mondo digitale, sia per quanto riguarda i modelli organizzativi. Gli elementi di confronto internazionale mostrano alcune debolezze del nostro Paese.
Almeno in parte, la ricerca qualitativa contribuisce a correggere queste indicazioni negative. Le imprese studiate si rivelano, infatti, assai capaci di rigenerare la tecnodiversità base del modello socioeconomico italiano a partire da un convinto investimento nelle persone, nei loro talenti e nelle loro competenze, sia direttamente – ad esempio sul fronte della formazione – sia indirettamente – agevolando quelle condizioni di base che consentono un coinvolgimento reciproco tra persone e imprese, più soddisfacente e di più lungo termine; così come gli interventi sul fronte della conciliazione tra vita professionale e familiare, sul tema salute o della casa raccontano.
Ciò ci dice che continua a esistere un gruppo anche relativamente nutrito (ma certamente ancora minoritario) di imprese capace di affrontare la transizione digitale senza perdere, anzi, rafforzando quella specificità che rende forte l’impresa Italia. Purtroppo, questo non riguarda l’intera popolazione imprenditoriale.
Il problema è quello di estendere a tutto il tessuto imprenditoriale queste attitudini, contrastando la tendenza (che ritorna sempre nel nostro sistema economico) a ripiegarsi, vuoi nella direzione di un progressivo sfruttamento delle risorse umane e tecniche con la riduzione degli investimenti e lo scarso investimento nei modelli organizzativi, vuoi nell’incapacità di ragionare in termini sistemici e di rete, adottando strategie competitive e/o di collaborazione con altri player nel lungo periodo. Un’altra polarizzazione tutta italiana che impedisce di coniugare spinta all’innovazione e “spirito di comunità” ingredienti che appaiono decisivi nell’immaginare lo sviluppo del Paese.
Un’ultima questione ha a che fare con il necessario processo di managerializzazione che sta interessando un numero crescente di imprese Italiane, anche in rapporto al ricambio generazionale di molte piccole e medie imprese. Ancora una volta, occorre andare al di là di una sterile contrapposizione tra la figura eroica dell’imprenditore e quella d’ordine del manager. Tale contrapposizione che si nutre di luoghi comuni ma anche di culture improprie costituisce un blocco da superare.
La chiave per andare oltre ha che fare con quanto emerge dai dati: il sistema delle imprese italiano ha bisogno di fare un salto nella sua qualità organizzativa, obiettivo che può essere raggiunto anche grazie al contributo di manager esperti. Ma ciò a condizione che la competenza manageriale non sia giocata nel senso di una normalizzazione del modello d’impresa italiano. Ma piuttosto come elemento in grado di superare i limiti legati all’eccessiva personalizzazione dell’esperienza imprenditoriale. Un passaggio particolarmente importante, tenendo conto del tema della transizione generazionale che interessa molte imprese del nostro Paese.
L’impresa e il territorio: verso organizzazioni neghentropiche
L’impresa e il territorio: verso organizzazioni neghentropiche
L’impresa italiana ha una tradizione di forte radicamento nel proprio territorio di appartenenza. La scarsa presenza di grandi imprese, il ruolo dei distretti industriali e la centralità delle piccole e medie imprese (PMI) sono elementi che hanno sempre legato le organizzazioni produttive al loro territorio di origine.
Dove il modello funziona, troviamo reti di interdipendenze geografiche di breve raggio che favoriscono collaborazioni locali; elevata flessibilità e capacità di risposta rapida alle esigenze del mercato, condivisione di competenze qualificate e innovazione attraverso modelli di collaborazione win-win, supporto finanziario integrato, che rafforza la resilienza delle imprese.
Lungo questa via il modello italiano ha sempre rifuggito l’eccesso di standardizzazione in favore di una forte biodiversità imprenditoriale che costituisce un elemento di ricchezza e di varietà fondamentale.
A questo schema tradizionale, le ultime trasformazioni aggiungono alcuni elementi interessanti.
In primo luogo, la nascita e lo sviluppo dell’impresa sociale. Si tratta di una novità del panorama dell’imprenditività italiane e che conferma e rinnova la tradizionale attenzione nei confronti del contesto circostante e dei suoi equilibri sociali.
I dati su questa realtà imprenditoriale in Italia sono eloquenti: l’Italia è il Paese con il maggior numero di forme giuridiche per l’impresa sociale (15), davanti a Polonia, Germania e Austria; il 43,2% delle risorse proviene da attività commerciali (secondo posto in Europa dopo la Svizzera; il 51,1% ha un modello di finanziamento ibrido.
Tra le forme più diffuse emergono le organizzazioni non profit e le startup innovative a vocazione sociale, un modello unico nel panorama europeo, caratterizzato da dinamismo e capacità di innovazione di processo e tecnologica. Questo settore rappresenta un universo di imprenditori e imprenditrici che contribuiscono attivamente alla generazione e redistribuzione del valore, confermando il ruolo centrale dell’imprenditività sociale nell’economia italiana.
La biodiversità imprenditoriale – intesa come varietà di settori, obiettivi economici, e forme giuridiche che valorizzano le specificità e le diversità di ciascun soggetto – costituisce senza dubbio una ricchezza che va salvaguardata e alimentata. Essa accresce il territorio di risorse di natura diversa, contribuendo allo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale maggiormente resiliente e inclusivo.
In secondo luogo, la matrice territoriale delle imprese italiane si traduce in una spiccata attenzione verso la sostenibilità ambientale. Ben il 45% delle aziende italiane ha dichiarato di non aver riscontrato particolari problemi nella transizione energetica.
Sul tema ambientale, l’Italia si conferma ben posizionata, collocandosi nella parte alta dei ranking di settore. Alcuni esempi: il nostro Paese si distingue per l’elevato numero di imprese che hanno adottato misure per ridurre l’uso di carta ed energia in relazione alle attrezzature ICT (70%, superiore alla media UE); nelle scelte di acquisto nel settore ICT, l’Italia si posiziona seconda in Europa, dopo il Portogallo; anche rispetto alle iniziative di riciclo ICT, il nostro Paese supera ampiamente la media UE.
Un modello economico di produzione e consumo particolarmente rilevante è quello dell’economia circolare, in cui l’Italia si colloca al quarto posto per investimenti privati (12.423 milioni di euro), anche se distanziata da Regno Unito (33.722 milioni) e Germania (31.507 milioni). In rapporto al PIL, l’Italia registra lo 0,7%, leggermente sotto la media UE (0,8%).
Per quanto riguarda il valore aggiunto generato dalla circular economy, l’Italia è terza in Europa (43.646 milioni di euro), pur restando ancora lontana da Germania (79.000 milioni) e Regno Unito. Tuttavia, il settore impiega il 2,4% della forza lavoro italiana, una percentuale significativamente superiore a quella tedesca (1,7%).
Nonostante questi risultati, il numero di brevetti e innovazioni nel settore non sembra essere all’altezza dell’impegno complessivo: 0,36 brevetti per milione di abitanti, contro una media UE di 0,46 e un dato tedesco di 0,55. Sebbene l’88% delle imprese italiane dichiari di aver intrapreso iniziative per la sostenibilità, gli investimenti finanziari per l’efficientamento delle risorse energetiche restano inferiori rispetto ad altri Paesi. Solo il 27% delle imprese ha destinato tra l’1% e il 5% del turnover a questi investimenti.
Si tratta di tendenze che possono essere considerate irreversibili, soprattutto se si considera che quasi l’80% dei giovani italiani considera l’impegno sociale e ambientale dell’impresa un criterio rilevante nella scelta lavorativa.
Inoltre, l’Italia si colloca tra i primi cinque Paesi in cui i giovani ritengono che la tutela delle persone debba essere una priorità per le aziende, segnando un cambiamento di sensibilità e valori, in particolare tra le nuove generazioni.
I segnali emergenti dall’analisi quantitativa vengono confermati anche dalla ricerca qualitativa, la quale consente di mettere a fuoco le logiche e le pratiche di un profilo di impresa che potrebbe segnare lo sviluppo imprenditoriale italiano dei prossimi anni.
Le indicazioni emergenti dalla ricerca suggeriscono che è in atto una metamorfosi nel rapporto tra l’impresa e il territorio che, se da una parte conferma lo stretto legame esistente (che le stesse imprese considerano vitale), dall’altra ne mette in evidenza i nuovi caratteri.
Si può parlare a questo proposito di “imprese neghentropiche” per indicare quei nuovi modelli imprenditoriali consapevoli del fatto che, per la loro stessa prosperità, sia imprescindibile perseguire un percorso di crescita che riduca gli effetti entropici dei processi economici. Una modalità che, da un lato, riguarda la vita interna delle stesse imprese attraverso l’adozione di strategie e politiche organizzative più evolute e una più ricca biodiversità imprenditoriale, e, dall’altro, la relazione con i propri interlocutori e l’ambiente sociale e naturale circostante.
Le interviste raccolte raccontano di imprese che, spesso a fronte di questioni più ampie ed esterne dell’organizzazione stessa, sono in grado di mobilitare e orientare intelligenze e risorse per immaginare e realizzare innovazioni capaci di generare valore multiforme – economico, sociale, culturale ed istituzionale – in grado di rilasciare effetti su molteplici piani per molteplici stakeholder. La logica è dialogica, connettiva e contributiva. L’approccio è integrale e dal respiro di medio-lungo periodo.
È interessante notare come, nei casi presi in esame, non si tratta mai di iniziative reattive o estemporanee. Piuttosto, i racconti restituiscono sperimentazioni inquadrabili dentro una precisa strategia di crescita e sviluppo del business. Nate da riflessioni più larghe che non raramente trovano ispirazione nella propria tradizione imprenditoriale, quasi un imprinting che ancora oggi permane e continua a rilasciare significati e orientamenti, queste stesse iniziative possono però essere avviate anche da nuove figure professionali e sociali in grado di interpretare l’intrapresa come via per coniugare, oggi, l’azione neghentropica con l’obiettivo decisivo della sostenibilità.
Il Rapporto, dunque, segnala una evoluzione importante in corso: il tradizionale modello della piccola e media impresa italiana radicato sul territorio si va trasformando in un modello più consapevole, che assume la sostenibilità economica e sociale non come vincolo formale, ma quale scelta strategica per rimanere competitivo e interpretare la tradizione imprenditoriale italiana in modo innovativo. Il contrasto all’entropia – come processo di frammentazione e dedifferenziazione che mina le stesse basi della crescita – costituisce uno scopo di cui le imprese più avvertite sono ben consapevoli. A differenza di quanto accadeva in passato, oggi non è possibile perseguire una crescita economica duratura se non ci si preoccupa di ricostruire le condizioni sociali e ambientali che la rendono possibile.
Sebbene non rappresenti ancora la maggioranza dell’imprenditoria italiana, questa linea di azione è perseguita con grande convinzione da parte di un’avanguardia imprenditoriale e manageriale dinamica, lucida e coraggiosa, che sta segnando nei fatti la linea del futuro del modello italiano.
L’impresa italiana ha una tradizione di forte radicamento nel proprio territorio di appartenenza. La scarsa presenza di grandi imprese, il ruolo dei distretti industriali e la centralità delle piccole e medie imprese (PMI) sono elementi che hanno sempre legato le organizzazioni produttive al loro territorio di origine.
Dove il modello funziona, troviamo reti di interdipendenze geografiche di breve raggio che favoriscono collaborazioni locali; elevata flessibilità e capacità di risposta rapida alle esigenze del mercato, condivisione di competenze qualificate e innovazione attraverso modelli di collaborazione win-win, supporto finanziario integrato, che rafforza la resilienza delle imprese.
Lungo questa via il modello italiano ha sempre rifuggito l’eccesso di standardizzazione in favore di una forte biodiversità imprenditoriale che costituisce un elemento di ricchezza e di varietà fondamentale.
A questo schema tradizionale, le ultime trasformazioni aggiungono alcuni elementi interessanti.
In primo luogo, la nascita e lo sviluppo dell’impresa sociale. Si tratta di una novità del panorama dell’imprenditività italiane e che conferma e rinnova la tradizionale attenzione nei confronti del contesto circostante e dei suoi equilibri sociali.
I dati su questa realtà imprenditoriale in Italia sono eloquenti: l’Italia è il Paese con il maggior numero di forme giuridiche per l’impresa sociale (15), davanti a Polonia, Germania e Austria; il 43,2% delle risorse proviene da attività commerciali (secondo posto in Europa dopo la Svizzera; il 51,1% ha un modello di finanziamento ibrido.
Tra le forme più diffuse emergono le organizzazioni non profit e le startup innovative a vocazione sociale, un modello unico nel panorama europeo, caratterizzato da dinamismo e capacità di innovazione di processo e tecnologica. Questo settore rappresenta un universo di imprenditori e imprenditrici che contribuiscono attivamente alla generazione e redistribuzione del valore, confermando il ruolo centrale dell’imprenditività sociale nell’economia italiana.
La biodiversità imprenditoriale – intesa come varietà di settori, obiettivi economici, e forme giuridiche che valorizzano le specificità e le diversità di ciascun soggetto – costituisce senza dubbio una ricchezza che va salvaguardata e alimentata. Essa accresce il territorio di risorse di natura diversa, contribuendo allo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale maggiormente resiliente e inclusivo.
In secondo luogo, la matrice territoriale delle imprese italiane si traduce in una spiccata attenzione verso la sostenibilità ambientale. Ben il 45% delle aziende italiane ha dichiarato di non aver riscontrato particolari problemi nella transizione energetica.
Sul tema ambientale, l’Italia si conferma ben posizionata, collocandosi nella parte alta dei ranking di settore. Alcuni esempi: il nostro Paese si distingue per l’elevato numero di imprese che hanno adottato misure per ridurre l’uso di carta ed energia in relazione alle attrezzature ICT (70%, superiore alla media UE); nelle scelte di acquisto nel settore ICT, l’Italia si posiziona seconda in Europa, dopo il Portogallo; anche rispetto alle iniziative di riciclo ICT, il nostro Paese supera ampiamente la media UE.
Un modello economico di produzione e consumo particolarmente rilevante è quello dell’economia circolare, in cui l’Italia si colloca al quarto posto per investimenti privati (12.423 milioni di euro), anche se distanziata da Regno Unito (33.722 milioni) e Germania (31.507 milioni). In rapporto al PIL, l’Italia registra lo 0,7%, leggermente sotto la media UE (0,8%).
Per quanto riguarda il valore aggiunto generato dalla circular economy, l’Italia è terza in Europa (43.646 milioni di euro), pur restando ancora lontana da Germania (79.000 milioni) e Regno Unito. Tuttavia, il settore impiega il 2,4% della forza lavoro italiana, una percentuale significativamente superiore a quella tedesca (1,7%).
Nonostante questi risultati, il numero di brevetti e innovazioni nel settore non sembra essere all’altezza dell’impegno complessivo: 0,36 brevetti per milione di abitanti, contro una media UE di 0,46 e un dato tedesco di 0,55. Sebbene l’88% delle imprese italiane dichiari di aver intrapreso iniziative per la sostenibilità, gli investimenti finanziari per l’efficientamento delle risorse energetiche restano inferiori rispetto ad altri Paesi. Solo il 27% delle imprese ha destinato tra l’1% e il 5% del turnover a questi investimenti.
Si tratta di tendenze che possono essere considerate irreversibili, soprattutto se si considera che quasi l’80% dei giovani italiani considera l’impegno sociale e ambientale dell’impresa un criterio rilevante nella scelta lavorativa.
Inoltre, l’Italia si colloca tra i primi cinque Paesi in cui i giovani ritengono che la tutela delle persone debba essere una priorità per le aziende, segnando un cambiamento di sensibilità e valori, in particolare tra le nuove generazioni.
I segnali emergenti dall’analisi quantitativa vengono confermati anche dalla ricerca qualitativa, la quale consente di mettere a fuoco le logiche e le pratiche di un profilo di impresa che potrebbe segnare lo sviluppo imprenditoriale italiano dei prossimi anni.
Le indicazioni emergenti dalla ricerca suggeriscono che è in atto una metamorfosi nel rapporto tra l’impresa e il territorio che, se da una parte conferma lo stretto legame esistente (che le stesse imprese considerano vitale), dall’altra ne mette in evidenza i nuovi caratteri.
Si può parlare a questo proposito di “imprese neghentropiche” per indicare quei nuovi modelli imprenditoriali consapevoli del fatto che, per la loro stessa prosperità, sia imprescindibile perseguire un percorso di crescita che riduca gli effetti entropici dei processi economici. Una modalità che, da un lato, riguarda la vita interna delle stesse imprese attraverso l’adozione di strategie e politiche organizzative più evolute e una più ricca biodiversità imprenditoriale, e, dall’altro, la relazione con i propri interlocutori e l’ambiente sociale e naturale circostante.
Le interviste raccolte raccontano di imprese che, spesso a fronte di questioni più ampie ed esterne dell’organizzazione stessa, sono in grado di mobilitare e orientare intelligenze e risorse per immaginare e realizzare innovazioni capaci di generare valore multiforme – economico, sociale, culturale ed istituzionale – in grado di rilasciare effetti su molteplici piani per molteplici stakeholder. La logica è dialogica, connettiva e contributiva. L’approccio è integrale e dal respiro di medio-lungo periodo.
È interessante notare come, nei casi presi in esame, non si tratta mai di iniziative reattive o estemporanee. Piuttosto, i racconti restituiscono sperimentazioni inquadrabili dentro una precisa strategia di crescita e sviluppo del business. Nate da riflessioni più larghe che non raramente trovano ispirazione nella propria tradizione imprenditoriale, quasi un imprinting che ancora oggi permane e continua a rilasciare significati e orientamenti, queste stesse iniziative possono però essere avviate anche da nuove figure professionali e sociali in grado di interpretare l’intrapresa come via per coniugare, oggi, l’azione neghentropica con l’obiettivo decisivo della sostenibilità.
Il Rapporto, dunque, segnala una evoluzione importante in corso: il tradizionale modello della piccola e media impresa italiana radicato sul territorio si va trasformando in un modello più consapevole, che assume la sostenibilità economica e sociale non come vincolo formale, ma quale scelta strategica per rimanere competitivo e interpretare la tradizione imprenditoriale italiana in modo innovativo. Il contrasto all’entropia – come processo di frammentazione e dedifferenziazione che mina le stesse basi della crescita – costituisce uno scopo di cui le imprese più avvertite sono ben consapevoli. A differenza di quanto accadeva in passato, oggi non è possibile perseguire una crescita economica duratura se non ci si preoccupa di ricostruire le condizioni sociali e ambientali che la rendono possibile.
Sebbene non rappresenti ancora la maggioranza dell’imprenditoria italiana, questa linea di azione è perseguita con grande convinzione da parte di un’avanguardia imprenditoriale e manageriale dinamica, lucida e coraggiosa, che sta segnando nei fatti la linea del futuro del modello italiano.
La cura dell’ecosistema
La terza dimensione da considerare nella tensione tra grande e piccola taglia è quella ecosistemica, una componente imprescindibile per le caratteristiche del tessuto produttivo italiano solidamente radicato con i propri territori d’elezione, anche alla luce degli evidenti errori compiuti a livello epistemologico ormai ampiamente superati dagli studi sulla complessità (l’idea dell’impresa come entità a sé che fa per sé).
Ogni economia avanzata – e ancor più in Italia con le sue caratteristiche peculiari – va infatti considerata come un insieme che vive e prospera grazie alla sua biodiversità interna; alla cura degli equilibri che costruisce tra le diverse tipologie di soggetti; e grazie alle relazioni che è in grado di tessere con l’ambiente circostante in cui è inserito.
L’idea tradizionale dell’impresa come realtà chiusa, autodefinita e autonoma rispetto a ciò che la circonda è sempre più fuorviante e inadeguata. In un contesto di sfide globali interconnesse, con sistemi economici funzionalmente interdipendenti – e nel caso italiano particolarmente articolati e centrati sulla micro e piccola media impresa – la crescita del sistema imprenditoriale nel suo insieme dipende dalla capacità di creare un ambiente integrato e coeso, capace di alimentare l’imprenditorialità diffusa, di accelerarne lo sviluppo, di massimizzarne l’impatto.
Un ecosistema imprenditoriale virtuoso non si esaurisce con la mera presenza di aziende capaci di comportamenti positivi di business. Esso richiede un’armonia tra istituzioni pubbliche e private, regolamentazioni burocratiche efficienti, un sistema formativo evoluto e qualificato, un accesso al credito plurale e semplificato, infrastrutture connettive moderne, affidabili e sicure, reti collaborative in grado di far circolare e redistribuire opportunità, conoscenza, risorse, fiducia. Solo attraverso queste sinergie è possibile trasformare idee in azioni concrete e liberare il potenziale imprenditoriale.
Questa complessità, quando non è governata, rischia fatalmente di tradursi in frammentazione, ampliando il senso di caos e di carenza di leadership, da un lato, ma anche lo spreco di energie dall’altro.
Oggi più che mai, la sopravvivenza delle imprese dipende da un supporto integrato che coniughi efficienza urbana, educazione avanzata, infrastrutture digitali e sicurezza giuridica. Senza interventi mirati, non solo si ostacola la crescita, ma si mette a rischio la tenuta stessa del capitale imprenditoriale nazionale.
L’analisi comparativa con i principali Paesi UE rivela alcuni ritardi strutturali.
Anzitutto, l’Italia è ultima in Europa per disponibilità di capitale proprio e di debito per le PMI, superata da Francia e Germania.
In secondo luogo, per quanto riguarda le politiche di sostegno, il nostro Paese è lontano dalle eccellenze (Lituania, Finlandia), anche se supera Germania e Spagna.
In terzo luogo, anche per quanto riguarda la qualità dei programmi per le PMI, il risultato dell’Italia non è soddisfacente, sebbene migliore di un Paese come la Spagna.
A conferma di quanto viene ripetuto da anni, l’Italia è ancora il secondo peggior sistema UE per quanto riguarda gli ostacoli burocratici e pressione fiscale (peggio di noi fa solo la Spagna).
In termini generali, il sistema Italia è tra i cinque Paesi meno efficaci, con un posizionamento molto distante da Germania, Francia e Nord Europa.
Su questi temi, di cui si parla da tempo, i risultati sono ancora deludenti e le conseguenze non possono non pesare sul sistema delle imprese.
Un ritardo analogo si registra sul nodo infrastrutture, rispetto al quale l’Italia si posiziona nella parte bassa della classifica europea, pari alla Germania, ma dietro a Francia e Spagna.
In definitiva, il Paese continua a disporre di un patrimonio imprenditoriale vitale, ma in un contesto ecosistemico che appare ancora ampiamente disorganizzato e ricco di lacune e incongruenze.
Per rafforzare la propria capacità competitiva, l’Italia ho bisogno di un piano integrato che agisca in modo armonico su sei leve:
- semplificazione burocratica e riduzione del cuneo fiscale;
- accesso al credito con strumenti innovativi (fondi garantiti, venture capital);
- rafforzamento R&D attraverso partnership pubblico-private;
- formazione avanzata con focus su competenze digitali e gestionali;
- infrastrutture abilitanti (logistica, banda ultralarga, energia verde);
- reti collaborative tra università, imprese e startup.
Solo un ecosistema solido, interconnesso e proiettato sull’innovazione può garantire alle PMI italiane di esprimere il proprio potenziale, trasformando le criticità attuali in opportunità per una crescita sostenibile e inclusiva.
Per essere in grado di poter accedere alle potenzialità della transizione globale, l’Italia ha bisogno di evolvere verso un sistema più coeso e dinamico, orientato all’innovazione, alla sostenibilità e alla competitività internazionale.
La terza dimensione da considerare nella tensione tra grande e piccola taglia è quella ecosistemica, una componente imprescindibile per le caratteristiche del tessuto produttivo italiano solidamente radicato con i propri territori d’elezione, anche alla luce degli evidenti errori compiuti a livello epistemologico ormai ampiamente superati dagli studi sulla complessità (l’idea dell’impresa come entità a sé che fa per sé).
Ogni economia avanzata – e ancor più in Italia con le sue caratteristiche peculiari – va infatti considerata come un insieme che vive e prospera grazie alla sua biodiversità interna; alla cura degli equilibri che costruisce tra le diverse tipologie di soggetti; e grazie alle relazioni che è in grado di tessere con l’ambiente circostante in cui è inserito.
L’idea tradizionale dell’impresa come realtà chiusa, autodefinita e autonoma rispetto a ciò che la circonda è sempre più fuorviante e inadeguata. In un contesto di sfide globali interconnesse, con sistemi economici funzionalmente interdipendenti – e nel caso italiano particolarmente articolati e centrati sulla micro e piccola media impresa – la crescita del sistema imprenditoriale nel suo insieme dipende dalla capacità di creare un ambiente integrato e coeso, capace di alimentare l’imprenditorialità diffusa, di accelerarne lo sviluppo, di massimizzarne l’impatto.
Un ecosistema imprenditoriale virtuoso non si esaurisce con la mera presenza di aziende capaci di comportamenti positivi di business. Esso richiede un’armonia tra istituzioni pubbliche e private, regolamentazioni burocratiche efficienti, un sistema formativo evoluto e qualificato, un accesso al credito plurale e semplificato, infrastrutture connettive moderne, affidabili e sicure, reti collaborative in grado di far circolare e redistribuire opportunità, conoscenza, risorse, fiducia. Solo attraverso queste sinergie è possibile trasformare idee in azioni concrete e liberare il potenziale imprenditoriale.
Questa complessità, quando non è governata, rischia fatalmente di tradursi in frammentazione, ampliando il senso di caos e di carenza di leadership, da un lato, ma anche lo spreco di energie dall’altro.
Oggi più che mai, la sopravvivenza delle imprese dipende da un supporto integrato che coniughi efficienza urbana, educazione avanzata, infrastrutture digitali e sicurezza giuridica. Senza interventi mirati, non solo si ostacola la crescita, ma si mette a rischio la tenuta stessa del capitale imprenditoriale nazionale.
L’analisi comparativa con i principali Paesi UE rivela alcuni ritardi strutturali.
Anzitutto, l’Italia è ultima in Europa per disponibilità di capitale proprio e di debito per le PMI, superata da Francia e Germania.
In secondo luogo, per quanto riguarda le politiche di sostegno, il nostro Paese è lontano dalle eccellenze (Lituania, Finlandia), anche se supera Germania e Spagna.
In terzo luogo, anche per quanto riguarda la qualità dei programmi per le PMI, il risultato dell’Italia non è soddisfacente, sebbene migliore di un Paese come la Spagna.
A conferma di quanto viene ripetuto da anni, l’Italia è ancora il secondo peggior sistema UE per quanto riguarda gli ostacoli burocratici e pressione fiscale (peggio di noi fa solo la Spagna).
In termini generali, il sistema Italia è tra i cinque Paesi meno efficaci, con un posizionamento molto distante da Germania, Francia e Nord Europa.
Su questi temi, di cui si parla da tempo, i risultati sono ancora deludenti e le conseguenze non possono non pesare sul sistema delle imprese.
Un ritardo analogo si registra sul nodo infrastrutture, rispetto al quale l’Italia si posiziona nella parte bassa della classifica europea, pari alla Germania, ma dietro a Francia e Spagna.
In definitiva, il Paese continua a disporre di un patrimonio imprenditoriale vitale, ma in un contesto ecosistemico che appare ancora ampiamente disorganizzato e ricco di lacune e incongruenze.
Per rafforzare la propria capacità competitiva, l’Italia ho bisogno di un piano integrato che agisca in modo armonico su sei leve:
- semplificazione burocratica e riduzione del cuneo fiscale;
- accesso al credito con strumenti innovativi (fondi garantiti, venture capital);
- rafforzamento R&D attraverso partnership pubblico-private;
- formazione avanzata con focus su competenze digitali e gestionali;
- infrastrutture abilitanti (logistica, banda ultralarga, energia verde);
- reti collaborative tra università, imprese e startup.
Solo un ecosistema solido, interconnesso e proiettato sull’innovazione può garantire alle PMI italiane di esprimere il proprio potenziale, trasformando le criticità attuali in opportunità per una crescita sostenibile e inclusiva.
Per essere in grado di poter accedere alle potenzialità della transizione globale, l’Italia ha bisogno di evolvere verso un sistema più coeso e dinamico, orientato all’innovazione, alla sostenibilità e alla competitività internazionale.
Il segno che rimane. Alla ricerca del nuovo spirito del capitalismo italiano
Il segno che rimane. Alla ricerca del nuovo spirito del capitalismo italiano
Il giro di boa che i rapidi cambiamenti geopolitici e tecnologici stanno imponendo mette l’limpresa italiana davanti a un crocevia epocale: come far transitare un patrimonio unico di valori che rischia di opacizzarsi se non rigenerato alla nuova fase storica che si va formando davanti ai nostri occhi?
La storia ci consegna un modello distintivo – creativo, umanistico, radicato nei territori – che ha fatto della qualità relazionale e della bellezza il suo tratto identitario. Un sistema che è prosperato grazie alla sua capacità di sviluppare una propria specificità produttiva (tecnodiversità), di mantenere una relazione vitale col territorio (neghentropia), nel quadro di una cura ecosistemica che ha sempre garantito una ricca biodiversità.
Oggi però questo DNA rischia di subire le implicazioni negative derivanti dal combinato disposto tra ipercompetizione globale, declino demografico e riduzione del dinamismo imprenditivo.
La via da percorrere è quella di valorizzare gli elementi distintivi del nostro modello economico senza indulgere nella retorica della “buona differenza”, ma lavorando attivamente per correggere i fattori distorsivi e ostativi che possono impedire quella metamorfosi di cui oggi c’è bisogno.
Il capitalismo italiano possiede anticorpi preziosi che vanno riscoperti e declinati in chiave contemporanea:
- l’umanesimo operativo
- la creatività sistemica
- il glocalismo virtuoso
- la resilienza generativa
L’umanesimo operativo costituisce un asset fondamentale nel quadro delle evoluzioni in atto. Parliamo della capacità di valorizzare e far interagire l’intelligenza relazionale e contestuale con la manualità esperta per mettere al mondo cose nuove, belle, efficaci e sostenibili in grado di rispondere ai bisogni delle persone. Una capacità che emerge con forza dalle interviste raccolte, le quali rimandano all’attitudine dell’impresa italiana di trovare nel “mettersi al servizio” delle persone e dei loro bisogni l’energia motivante e di senso. Esemplari, a questo riguardo, sono le interviste a CAIMI o al Gruppo Magister.
Fondamentale è anche la creatività sistemica. Parliamo della fusione tra l’artigianalità estetica e l’artigiania tecnica, un sapere che fonda la straordinaria tecnodiversità del Paese. Ciò si sviluppa all’interno di una cosmologia che attraversa territori diversi è che funziona da stimolo che rende possibile quella creatività che rimane il segno distintivo del nostro Paese. Che sa ragionare in maniera transettoriale e sistemica, facendo dialogare e coniugando in modo originale materiali, strumenti, risorse, conoscenze, abilità. L’esperienza di ELICA, che alimenta l’innovazione a partire dall’incrocio con l’arte moderna, o di INDITEX, che fa della fragilità umana un’occasione di potenziamento delle competenze organizzative, sono begli esempi di creatività sistemica. Creatività sistemica è anche la ricerca della “lavoro ben fatto” che nel rispondere di criteri plurimi di funzionalità e di efficacia, di bellezza e di eticità, è riconosciuto nel mondo nel label “Made in Italy”.
Non meno vincente è il glocalismo virtuoso, ben tradotto dalle imprese italiane presso le quali il radicamento territoriale convive nell’interazione con reti globali. È l’impresa capace di aprirsi senza smarrirsi o isolarsi, che moltiplica opportunità e non ne sottrae, anche grazie alla capacità di mantenersi centrata sulla relazione di reciprocità e di portare una “sua” misura delle cose, parametrata sull’umano (impresa neghentropica). Una tensione che si ritrova fortemente nell’intervista a Loccioni o a Dallara, con la loro capacità di restare profondamente locali e non di meno globali. O nell’esperienza della Fondazione di Padernello, catalizzatrice di processi di rigenerazione territoriale di natura non localistica.
Infine, a fare la differenza sarà la resilienza generativa, intesa come adattabilità dell’impresa senza snaturamento identitario. Ovvero l’abilità di farsi promotori del cambiamento dentro una continuità di intenti. Anche a questo proposito le interviste, rimandano ad una forte coerenza biografica che fa da bussola in tempi incerti, ma anche diventa vantaggio distintivo e dunque competitivo.
Una competenza che diventa la forza di Edison, di ATM oggi anche nell’attraction e nella retention, o di Riso Gallo e di Andriani, nello sviluppo di nuovi prodotti frutto di una nuova agricoltura sostenibile.
Questi caratteri non sono folklore da museo, ma asset competitivi da reimmaginare. La vera questione dell’impresa italiana non è la dimensione – piccola o grande – ma l’incapacità di tradurre oggi questi valori in modelli organizzativi scalabili e in ecosistemi qualificati, senza perdere la sua natura originaria.
La doppia transizione digitale e generazionale costituisce per il nostro Paese un giro di boa particolarmente impegnativo, anche alla luce dei ritardi elencati.
Un passaggio da gestire con una duplice attenzione: su un fronte, integrando il digitale come abilitatore, piuttosto che come sostituto numerico dell’umano; sull’altro, investire nel ricambio generazionale preservando, riattualizzandola, la memoria d’impresa.
Questa metamorfosi richiede un nuovo alfabeto gestionale che coniughi:
- tecnologia abilitante (AI, IoT) con **saperi incarnati** dalle persone, dalle imprese, dai territori;
- processi agili con relazioni di fiducia
- open Innovation con autenticità dei prodotti.
Il compito storico è chiaro: evitare la deriva della barca Italia tra due estremi – la dedifferenziazione omologante e l’isolamento provincialista e involutivo/protettivo, ma anche tirare dritto, e mancare quel giro di boa che consentirebbe al Paese di restare in gara.
Fondamentale, in questa transizione, sarà la capacità di affrontare alcune questioni di fondo che appaiono in questo momento storico di assoluta necessità:
- un nuovo patto formazione-impresa per coltivare competenze ibride (tecnico-umanistiche)
- ecosistemi regionali come laboratori di sperimentazione glocal
- finanza paziente che premi l’originalità sulla standardizzazione.
In questa fase storica così critica, l’Italia può scrivere un capitolo inedito: dimostrare che produrre valore economico non è antitetico a creare bellezza e che efficienza numerica e human touch possono coesistere. Non si tratta di tornare al passato, ma di reincarnare lo spirito pionieristico delle origini in forme contemporanee.
Il futuro chiede alle imprese italiane di diventare ambasciatrici di un capitalismo umano-centrico, dove il profitto sia misura non solo di efficienza economica, ma di capacità di elevare comunità e paesaggi. Questa non è utopia: è l’unico realismo possibile per un Paese che vuole sfuggire al declino senza tradire sé stesso.
La terza dimensione da considerare nella tensione tra grande e piccola taglia è quella ecosistemica, una componente imprescindibile per le caratteristiche del tessuto produttivo italiano solidamente radicato con i propri territori d’elezione, anche alla luce degli evidenti errori compiuti a livello epistemologico ormai ampiamente superati dagli studi sulla complessità (l’idea dell’impresa come entità a sé che fa per sé).
Ogni economia avanzata – e ancor più in Italia con le sue caratteristiche peculiari – va infatti considerata come un insieme che vive e prospera grazie alla sua biodiversità interna; alla cura degli equilibri che costruisce tra le diverse tipologie di soggetti; e grazie alle relazioni che è in grado di tessere con l’ambiente circostante in cui è inserito.
L’idea tradizionale dell’impresa come realtà chiusa, autodefinita e autonoma rispetto a ciò che la circonda è sempre più fuorviante e inadeguata. In un contesto di sfide globali interconnesse, con sistemi economici funzionalmente interdipendenti – e nel caso italiano particolarmente articolati e centrati sulla micro e piccola media impresa – la crescita del sistema imprenditoriale nel suo insieme dipende dalla capacità di creare un ambiente integrato e coeso, capace di alimentare l’imprenditorialità diffusa, di accelerarne lo sviluppo, di massimizzarne l’impatto.
Un ecosistema imprenditoriale virtuoso non si esaurisce con la mera presenza di aziende capaci di comportamenti positivi di business. Esso richiede un’armonia tra istituzioni pubbliche e private, regolamentazioni burocratiche efficienti, un sistema formativo evoluto e qualificato, un accesso al credito plurale e semplificato, infrastrutture connettive moderne, affidabili e sicure, reti collaborative in grado di far circolare e redistribuire opportunità, conoscenza, risorse, fiducia. Solo attraverso queste sinergie è possibile trasformare idee in azioni concrete e liberare il potenziale imprenditoriale.
Questa complessità, quando non è governata, rischia fatalmente di tradursi in frammentazione, ampliando il senso di caos e di carenza di leadership, da un lato, ma anche lo spreco di energie dall’altro.
Oggi più che mai, la sopravvivenza delle imprese dipende da un supporto integrato che coniughi efficienza urbana, educazione avanzata, infrastrutture digitali e sicurezza giuridica. Senza interventi mirati, non solo si ostacola la crescita, ma si mette a rischio la tenuta stessa del capitale imprenditoriale nazionale.
L’analisi comparativa con i principali Paesi UE rivela alcuni ritardi strutturali.
Anzitutto, l’Italia è ultima in Europa per disponibilità di capitale proprio e di debito per le PMI, superata da Francia e Germania.
In secondo luogo, per quanto riguarda le politiche di sostegno, il nostro Paese è lontano dalle eccellenze (Lituania, Finlandia), anche se supera Germania e Spagna.
In terzo luogo, anche per quanto riguarda la qualità dei programmi per le PMI, il risultato dell’Italia non è soddisfacente, sebbene migliore di un Paese come la Spagna.
A conferma di quanto viene ripetuto da anni, l’Italia è ancora il secondo peggior sistema UE per quanto riguarda gli ostacoli burocratici e pressione fiscale (peggio di noi fa solo la Spagna).
In termini generali, il sistema Italia è tra i cinque Paesi meno efficaci, con un posizionamento molto distante da Germania, Francia e Nord Europa.
Su questi temi, di cui si parla da tempo, i risultati sono ancora deludenti e le conseguenze non possono non pesare sul sistema delle imprese.
Un ritardo analogo si registra sul nodo infrastrutture, rispetto al quale l’Italia si posiziona nella parte bassa della classifica europea, pari alla Germania, ma dietro a Francia e Spagna.
In definitiva, il Paese continua a disporre di un patrimonio imprenditoriale vitale, ma in un contesto ecosistemico che appare ancora ampiamente disorganizzato e ricco di lacune e incongruenze.
Per rafforzare la propria capacità competitiva, l’Italia ho bisogno di un piano integrato che agisca in modo armonico su sei leve:
- semplificazione burocratica e riduzione del cuneo fiscale;
- accesso al credito con strumenti innovativi (fondi garantiti, venture capital);
- rafforzamento R&D attraverso partnership pubblico-private;
- formazione avanzata con focus su competenze digitali e gestionali;
- infrastrutture abilitanti (logistica, banda ultralarga, energia verde);
- reti collaborative tra università, imprese e startup.
Solo un ecosistema solido, interconnesso e proiettato sull’innovazione può garantire alle PMI italiane di esprimere il proprio potenziale, trasformando le criticità attuali in opportunità per una crescita sostenibile e inclusiva.
Per essere in grado di poter accedere alle potenzialità della transizione globale, l’Italia ha bisogno di evolvere verso un sistema più coeso e dinamico, orientato all’innovazione, alla sostenibilità e alla competitività internazionale.