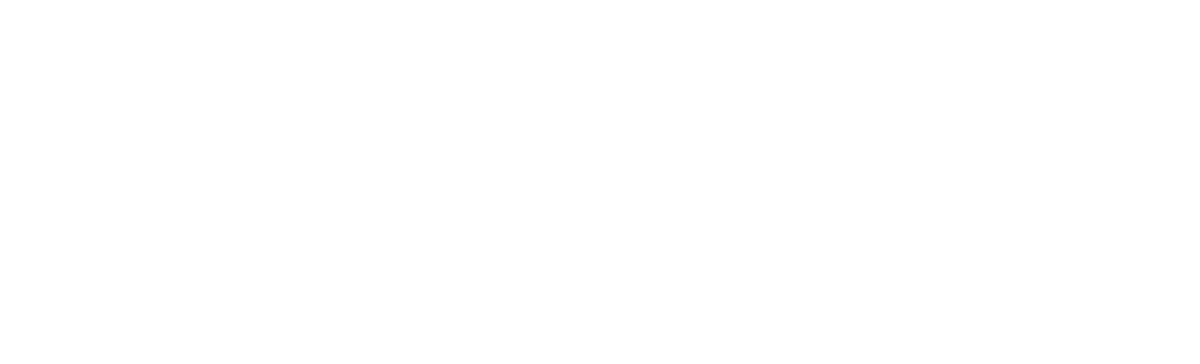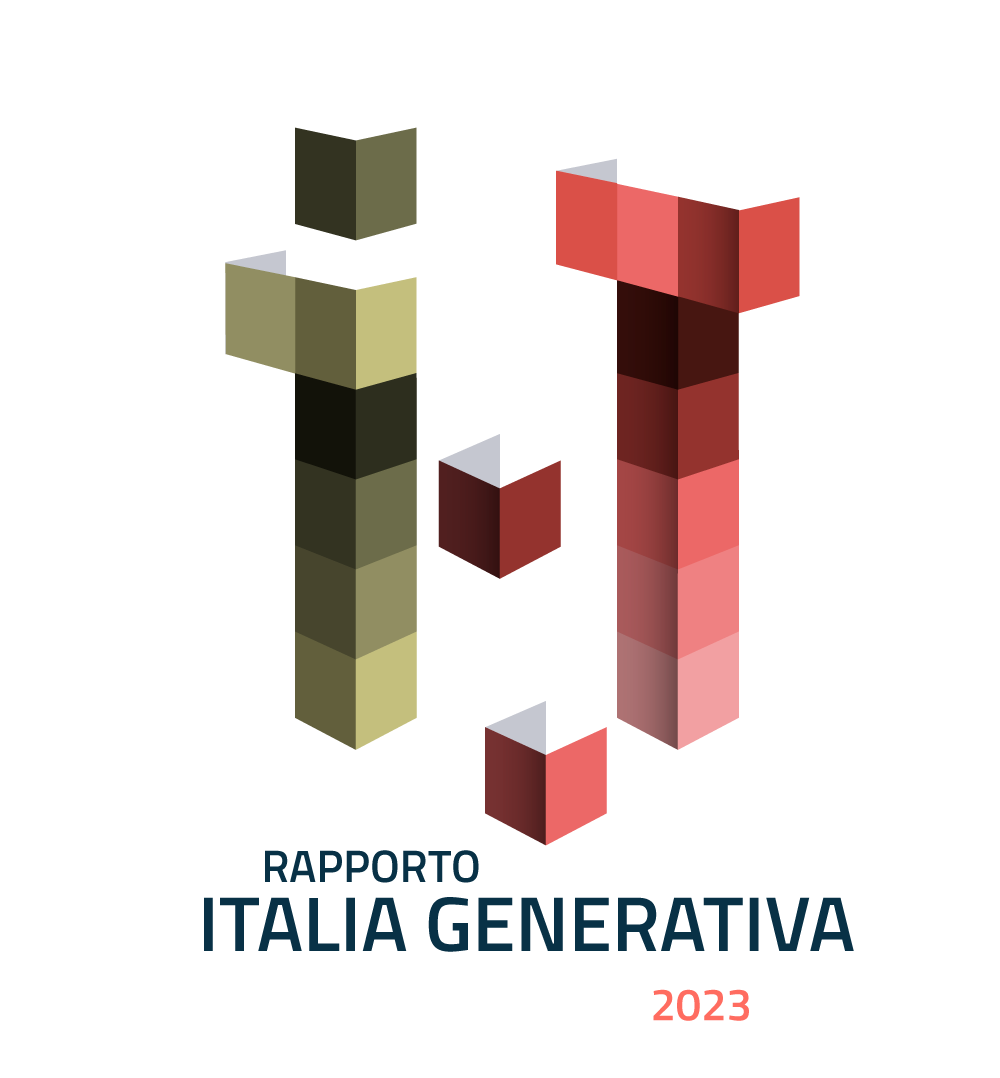PREFAZIONE
L’IMPRENDITIVITÀ COME INDICE
DI GENERATIVITÀ SOCIALE
Presentazione del Rapporto Italia Generativa 2024
L’imprenditività rappresenta un indicatore fondamentale della vitalità di una comunità. Essa incarna la generatività sociale, poiché presuppone la capacità di assumersi il rischio dell’iniziativa. Parliamo di generatività sociale per raccontare la possibilità di dare inizio a nuovi processi e a nuove forme sociali produttive di senso, quale contributo libero, originale e migliorativo alla vitalità dei diversi ecosistemi da parte di persone, gruppi, organizzazioni e istituzioni.
In questo modo è possibile rigenerare continuamente la vita sociale ed economica, liberando sempre nuove opportunità di esistenza e di sviluppo per altri, presenti e futuri.
Avviare un’impresa è, in senso arendtiano, un atto di nascita: un’apertura verso il nuovo, un apporto che in modo multiforme arricchisce il mondo.
Intraprendere significa dare vita a una nuova storia, il cui successo non riguarda solo l’individuo, ma l’intero contesto in cui si inserisce.
Si tratta, senza dubbio, di un’azione economica nel suo significato più profondo che rimanda, a partire dal suo etimo, alla “gestione della casa”, ovvero alla cura di qualcosa di comune. Tuttavia, nella sua struttura si cela una dinamica più profonda. Ogni iniziativa si rivela, infatti, un atto di fiducia nella vita e nel futuro e si innesta nella capacità umana di scorgere opportunità laddove c’è un problema o un bisogno; di immaginare un domani che ancora non esiste; di mobilitare e orientare altre risorse per realizzarlo.
Non a caso, Keynes ha parlato di “spiriti animali” per indicare la carica vitale che muove l’iniziativa imprenditoriale.
È il desiderio, in ultima analisi, a innescare il movimento dell’intrapresa, mentre la capacità organizzativa – con tutte le risorse e le competenze necessarie – ne assicura la piena attuazione. L’organizzazione è essenziale affinché un’iniziativa possa crescere e durare nel tempo, ovvero garantirsi quella sostenibilità economica che non può essere disgiunta dalla sostenibilità sociale. Si tratta, dunque, di testimoniare quel desiderio con un’azione di cura, grazie alla quale tutto si lega per potere prosperare in modo equilibrato e sano.
L’imprenditività diventa così una lente attraverso cui interpretare il livello di vitalità di un Paese.
È questo il motivo per cui il Rapporto Italia Generativa 2024 è dedicato a questo tema: senza la capacità di esercitare il processo di “distruzione creatrice” di cui parlava J. Schumpeter, le forme economiche esistenti rischiano di invecchiare e irrigidirsi, perdendo via via la tensione verso l’avvenire, portando al declino economico e sociale.
Venendo alla sua struttura, il Rapporto si articola in due parti, la prima quantitativa, la seconda qualitativa.
La prima parte è ordinata in quattro capitoli che esplorano, da altrettante angolazioni, l’imprenditività in una prospettiva comparativa con l’Europa: i suoi dinamismi e i blocchi; la biodiversità degli attori e delle forme, ovvero l’intreccio tra la dimensione del sapere dell’umano con la logica economica e normativa; gli immaginari e le percezioni attorno all’intraprendere; infine, l’imprenditività alla luce di tre passaggi epocali, ovvero le transizioni digitale, ecologica e organizzativa.
La parte qualitativa propone, invece, una serie di interviste a figure apicali di alcune realtà italiane, piccole, medie e grandi, che, in forme diverse, mostrano come la spinta imprenditiva si traduca nella capacità di sapersi rinnovare anche attraverso l’integrazione con e la cura del contesto in cui si opera. Andando a rispondere a nuove questioni emergenti che impattano sulla sostenibilità e sul proprio ecosistema, l’intrapresa genera/rigenera le condizioni per il suo stesso esistere e prosperare, in un dialogo incessante con ciò che le circonda e che inevitabilmente le attraversa.
Il Rapporto si conclude con alcune considerazioni finali che, rileggendo i dati raccolti, si sviluppano attorno a cinque questioni nodali a cui corrispondono altrettante domande chiave.
La prima riguarda lo stato dell’imprenditività italiana: è ancora un fenomeno pulsante e dinamico, oppure ha perso slancio ed energia? Quali fattori contribuiscono a modellare il quadro attuale? Cosa alimenta o, al contrario, ne ostacola lo sviluppo?
La seconda questione si concentra sui soggetti sociali che incarnano oggi la spinta imprenditiva. Chi guida le dinamiche dell’intrapresa? Si è accorciato l’orizzonte temporale, o resiste uno sguardo lungo delle imprese? Da dove provengono, o potrebbero provenire, nuove energie e visioni? L’aspirazione all’intrapresa si traduce in azione concreta, nell’idea del fare insieme, o rimane un desiderio inespresso? Quali sono gli ostacoli e quali i fattori abilitanti?
Un terzo passaggio pone il tema dei nuovi modelli e degli originali sistemi di governance d’impresa in continua evoluzione: quali culture imprenditoriali stanno generando valore condiviso e qualità della vita di lavoro, senza limitarsi alla mera estrazione di risorse? Se emerge la necessità di un cambiamento, quale è l’orizzonte verso cui tendere? E quali imprese si stanno muovendo in questa direzione?
Il quarto nodo curva sull’ecosistema, inteso come il contesto che può fungere da incubatore e acceleratore dell’intrapresa economica. Quali risorse e strumenti sono ancora disponibili nel nostro Paese? Per quanto tempo lo saranno? Cosa manca affinché la propensione all’imprenditività possa tradursi in realtà concreta, anziché rimanere un semplice sogno? E, infine, come può un’iniziativa trasformarsi in una realtà capace di crescere, resistere e generare valore nel tempo?
L’ultimo interrogativo che le considerazioni finali rilanciano riguarda il che fare: da dove partire per invertire la rotta? Quali azioni sono necessarie per rilanciare l’imprenditività in Italia?